- Accedi
- Registrati
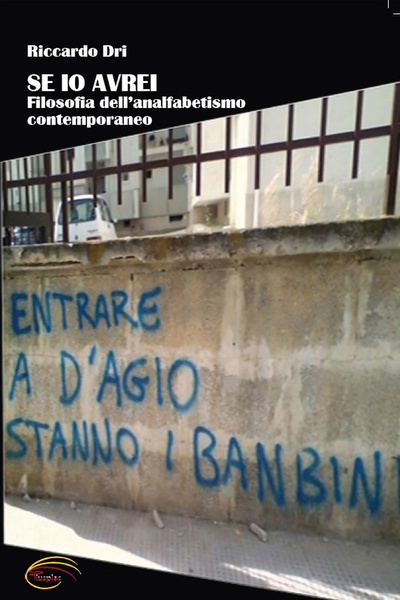
Filosofia dell'analfabetismo contemporaneo
17,00 €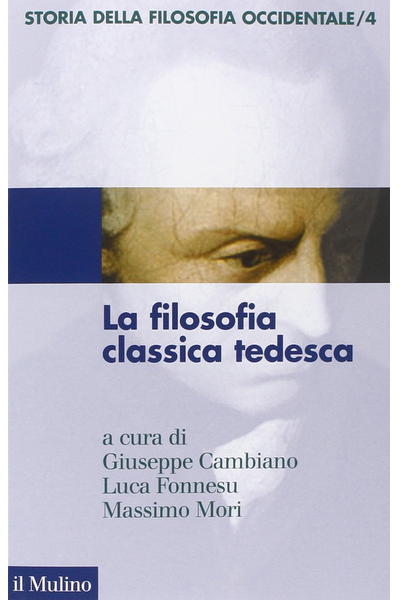
La filosofia classica tedesca
17,60 €
Saggio per un'interpretazione filosofica
15,90 €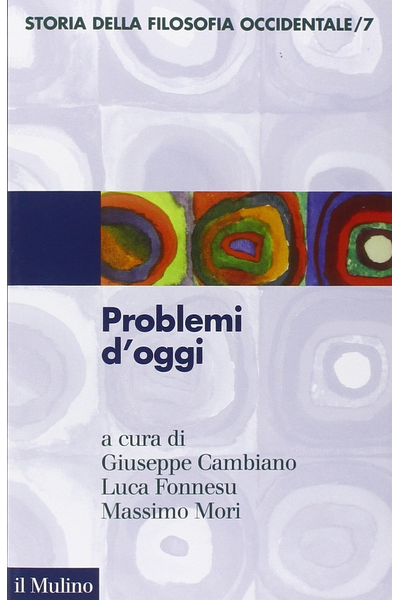
Problemi d'oggi
18,40 €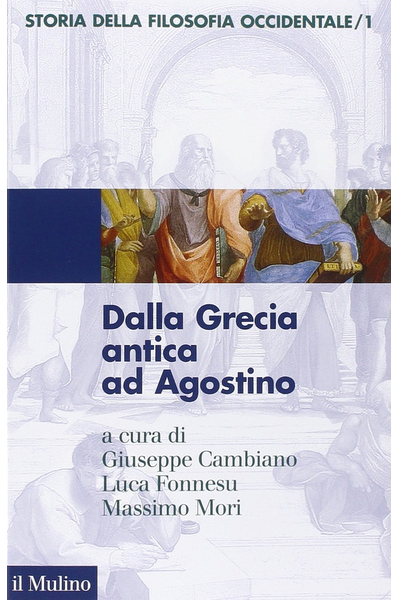
Dalla Grecia antica ad Agostino
22,40 €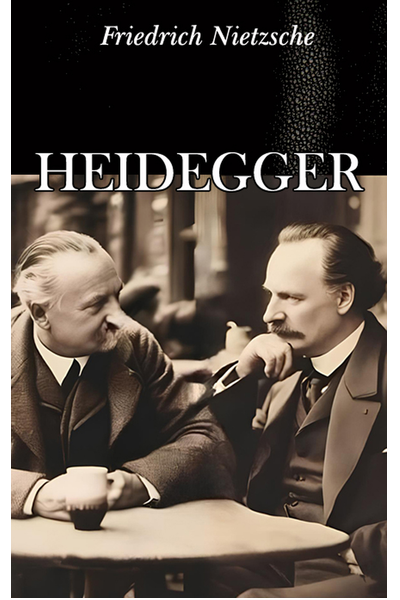
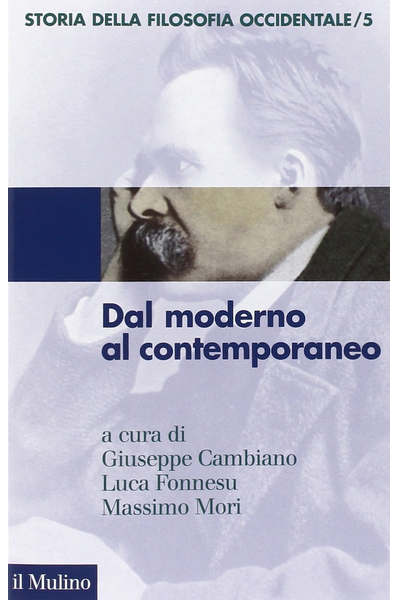
Dal moderno al contemporaneo
20,80 €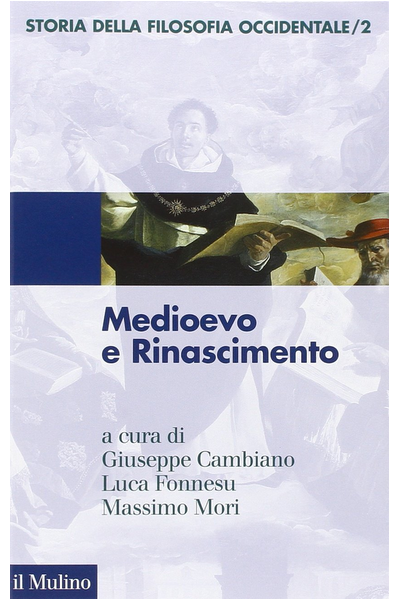
Medioevo e rinascimento
22,40 €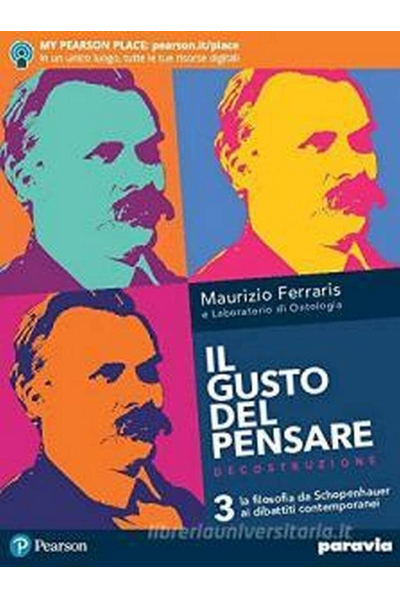
La filosofia da Schopnhauer ai dibattiti contemporanei
40,10 €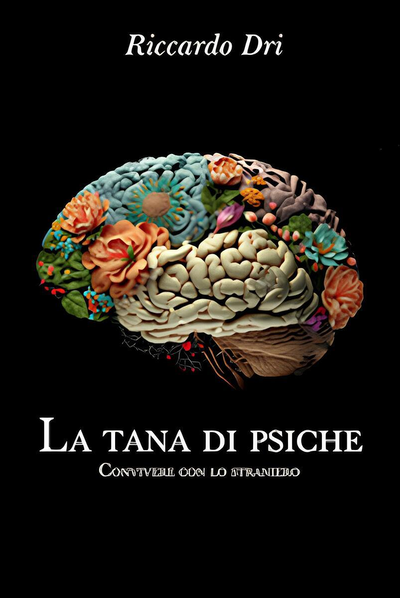
Convivere con lo straniero
23,66 €
A cinquant’anni dalla morte di Aldo Capitini (1899-1968), merita riproporre la lettura e la meditazione di Religione aperta, uno dei suoi scritti fondamentali.
Una originale e profonda lezione di religiosità laica è quella che possiamo attingere da quest’opera, impreziosita non solo da una schietta riflessione teorica, ma anche e soprattutto dalla testimonianza di una coerente prassi di vita, quale è stata quella di questo grande maestro italiano del pensiero nonviolento.
Ho pensato di riportare gran parte del primo capitolo “La mia persuasione religiosa” perché mi pare riassuma bene la sua laica e aperta religiosità.
«Ho lasciato la pratica della religione cattolica da ragazzo. Sono tornato ad occuparmi di temi religiosi, dopo circa sei anni, alla fine della prima guerra mondiale, ma senza riprendere precisamente né la pratica né la fede della religione tradizionale. Di “religioso” c’erano nel mio animo e nella mia ricerca intellettuale questi elementi: 1, il superamento del patriottismo scolastico in una disposizione umanitaria e internazionalistica, nella scoperta del principio supremo dell’amore fra tutti; 2, il distacco dalle valutazioni di una civiltà attivistica secondo ciò che uno può fare e affermare, e l’attenzione a chi non può fare, a chi si aggira esaurito per le strade e tra il lavoro degli altri, a chi è sofferente, ed è messo al margine della vita; 3, il rifiuto della considerazione della vita della giovinezza secondo i godimenti, le varie esperienze, la fortuna, apprezzando, invece, la fedeltà a “voti” di rinuncia e a un indirizzo moralmente rigoroso; 4, la ricostruzione della mia cultura su basi classiche, dopo l’esperienza dei moderni e dei contemporanei perfino estremisti. Il nazionalismo, il dannunzianesimo, il futurismo, restarono alle mie spalle, e ripresi, in fondo, la sincerità, la serietà, l’apertura del fanciullo di prima dei dieci anni. Il Leopardi, il Manzoni, Virgilio, il Vangelo, guidarono la ricostruzione dopo la parentesi di dispersione e di enfasi. Ero in una posizione morale, e in politica, attento (ma non professante) alle esigenze socialiste.
Il periodo che seguì, quello che nella società nazionale fu del fascismo, mi porto ad usare il termine di “religione” con una precisa intenzione e per concrete ragioni. Davanti al potere della violenza e davanti a quel falso classicismo, che era invece accademia e autoritarismo esteriore; e davanti al fatto che l’istituzione religiosa tradizionale nessun aiuto dava a contrastare ad un regime che era sbagliato dai punti di vista della libertà, della socialità, dell’educazione, mi trovai costretto a risalire direttamente ai maestri di vita religiosa, a contatto prossimo con quello spirito e quel metodo: Gesù Cristo, Buddha, san Francesco, Mazzini, Gandhi. Non dubitai di poter usare la parola di “religiosa” per la posizione che concretai: di fede in Dio, nella nonviolenza, nella nonmenzogna, nella noncollaborazione con ciò che crediamo un male e rivalutazione affettuosa per i sofferenti, i minimi, gli ultimi. […] Ma non vorrei che queste parole dessero l’impressione che la persuasione religiosa che mi ero costituito, fosse una formazione culturale. Se la cultura mi giovò, per rendermi meglio conto del carattere leggendario di tanti “fatti” collocati dalla tradizione alle origini del cristianesimo, per articolare e prendere migliore coscienza degli sviluppi di una libera posizione religiosa, e per osservare più informatamente nell’orizzonte del mondo il tramonto delle vecchie posizioni religiose e politiche; sono certo che anche senza cultura sarei arrivato ai punti essenziali della mia persuasione religiosa, a cui tendevo, si può dire, da fanciullo, ma che le vicende della vita, unite come sono ai sentimenti e alla riflessione, mi fecero concretare: sapere della guerra, conoscere direttamente il dolore e insistentemente, soffrire l’esaurimento, l’insonnia, la fragilità fisica, sperimentare il male morale, non accettare la violenza, interessarsi ai singoli, vivere in povertà, tendere ad associarsi per lottare politicamente, possono essere anche in una persona senza speciale cultura, e loro mi hanno condotto ad una vita religiosa.
Quando incontro una persona, e anche un semplice animale, non posso ammettere che poi quell’essere vivente se ne vada nel nulla, muoia e si spenga, prima o poi, come una fiamma. Mi vengono a dire che la realtà è fatta così, ma io non accetto. E se guardo meglio, trovo anche altre ragioni per non accettare la realtà così com’è ora, perché non posso approvare che la bestia più grande divori la bestia più piccola, che dappertutto la forza, la potenza, la prepotenza prevalgano: una realtà fatta così non merita di durare. È una realtà provvisoria, insufficiente, ed io mi apro ad una sua trasformazione profonda, ad una sua liberazione dal male nelle forme del peccato, del dolore, della morte.
[…]
La religione è semplicemente un insieme di pensiero e di azione, di princìpi e di atti (che possono anche accrescersi e variare) allo scopo di preparare e formare in noi l’apertura religiosa. Ma ciò che conta non è di avere sempre la religione, ma che venga una realtà liberata che comprenda tutti; e perciò incontriamo ogni persona, ogni essere, senza l’apprensione che possa finire, e con la gioia di essere in seguito sempre più uniti e cooperanti, verso delle realtà aperte che non possiamo descrivere». (pp. 5-7)
Aggiunto il 18/11/2018 18:50 da Alfio Fantinel
Argomento: Filosofia contemporanea
Pagine: 248
Edizione: 2011
Scritto da: Aldo Capitini
Lingua: Italiano
Costo: 20,00 €
Casa editrice: Laterza
ISBN: 978-88-420-9716-7

Fin dalle origini la filosofia occidentale ha cercato di liberare il pensiero dall'enorme scandalo rappresentato dal nulla assoluto, proibendo persino di nominarlo (Parmenide), oppure volgendo lo sgua..

In questa introduzione alla filosofia di Hegel il pensiero del filosofo tedesco è spiegato in termini chiari e accessibili, ripercorrendone lo sviluppo attraverso i contenuti delle opere principali, p..