- Accedi
- Registrati
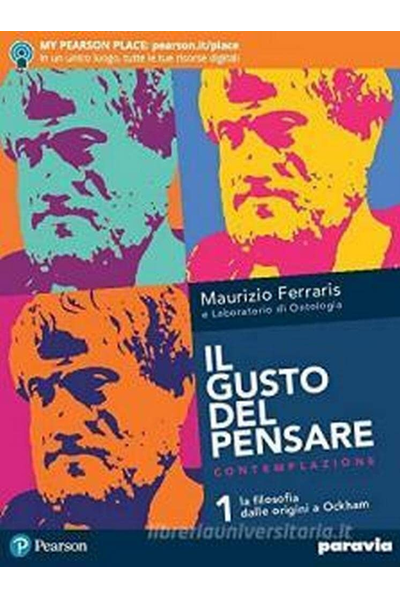
La filosofia dalle origini a Ockham
31,20 €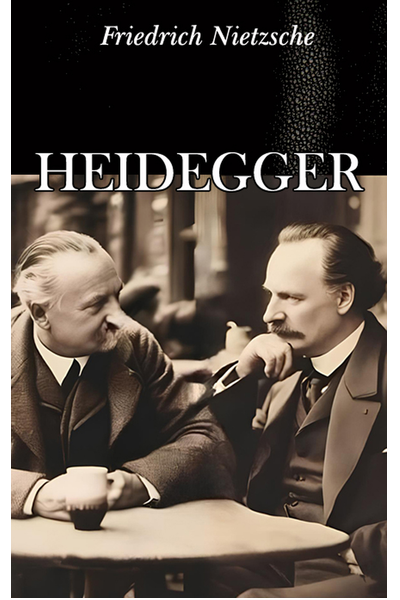
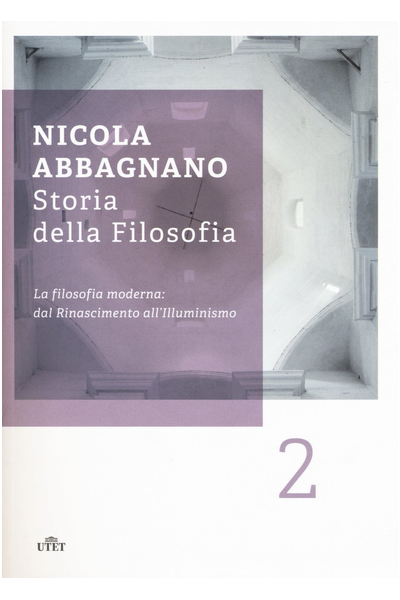
La filosofia moderna: dal Rinascimento all'Illuminismo
27,07 €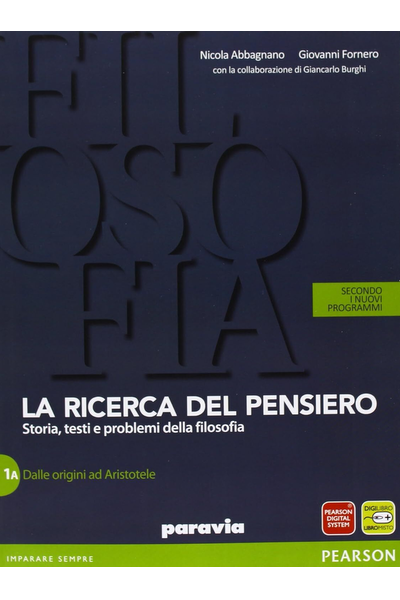
Dalle origini ad Aristotele
40,10 €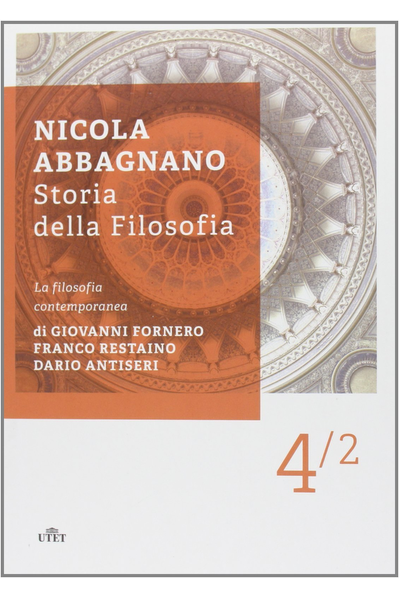
La filosofia contemporanea
30,40 €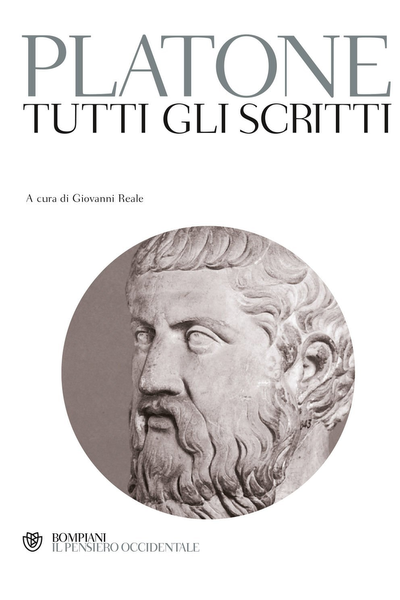
Tutti gli scritti
60,00 €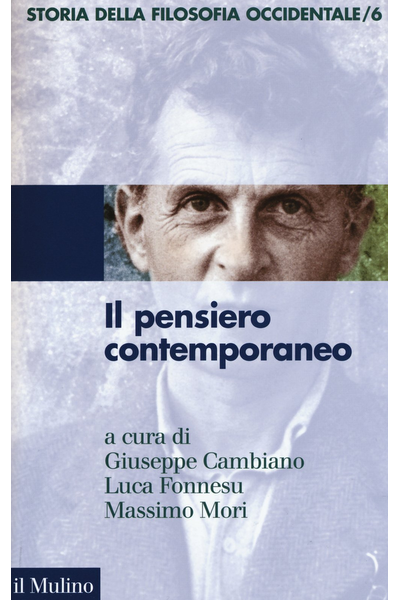
Il pensiero contemporaneo
22,40 €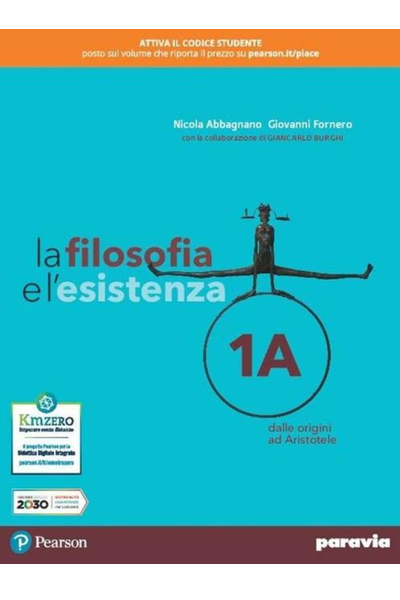
Dalle origini ad Aristotele
39,70 €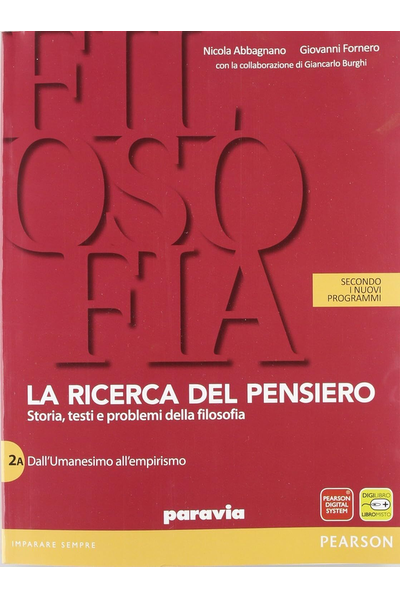
Dall'Umanesimo all'empirismo
52,90 €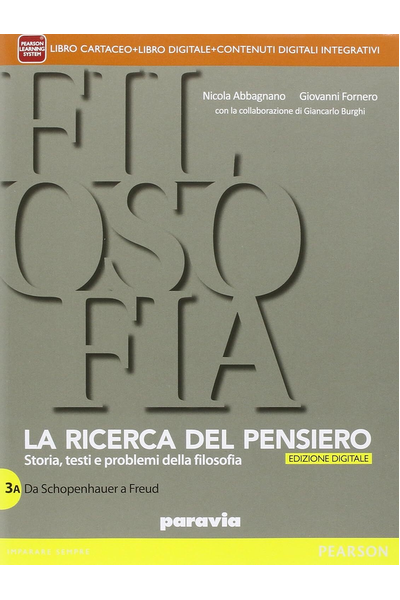
Da Schopenhauer a Freud
52,50 €Il naufrago e la fanciulla (Odissea θ,
457-468)
Nell’ Odissea, poema del mare, all’eroe tocca
fare esperienza del naufragio e del dovere la propria salvezza ad una
fanciulla. Poco importa se, per le esigenze della fiaba, ella sia la figlia del
re. Non con le rituali nozze, infatti, si concluderà l’incontro fra Odisseo e
Nausicaa, ma con un più realistico addio: un episodio molto breve del poema, ma denso di umano significato.
Odisseo, naufrago nella terra dei Feaci, è stato
qui accolto come ospite. Rifocillato, lavato e rivestito, è stato restituito
alla sua dignità umana. Ricchi doni gli sono stati offerti e gli è stato
garantito l’aiuto per ritornare nella sua terra e dalla sua famiglia, per cui
soffre di nostalgia: il dolore (algos)
per un ritorno (nostos) troppo a
lungo mancato. Ora sta per prendere congedo dai suoi benefattori ed è atteso
nel megaron. Qui, dove arde il
focolare e si banchetta, è il microcosmo della comunità, il luogo della
rappresentazione dell’ordine etico e civile dove Odisseo è riammesso nella
pienezza del suo status. Ma prima deve saldare il suo debito con colei che,
come una seconda madre, gli ha ridato la vita ed ha permesso il suo reintegro
nell’umana comunità, Nausicaa. Ella lo attende all’ingresso del megaron, dove non può entrare perché
nubile fanciulla. “Ma Nausicaa, alla quale gli dei donano bellezza, si ferma
allora accanto al pilastro del tetto saldamente costruito.” Davanti ad Odisseo
splende la bellezza della giovane donna, dono degli dei, vera bellezza, fisica
e morale insieme, che trapassa da una dimensione all’altra. Ma anche Nausicaa
“guardava con ammirazione Odisseo fissandolo con gli occhi e, avendo cominciato
a parlare, gli rivolgeva parole alate”. Lungo dovrà essere il volo delle parole
di Nausicaa, affinché accompagnino Odisseo nel suo ritorno in patria. “Abbi
fortuna e sii felice, forestiero e ospite”: in greco un’unica parola, xenos, indica lo straniero e l’ospite,
perché ricevere ospitalità è un diritto, sul quale vegliano gli dei, di
chiunque giunga da fuori, qualunque sia la sua identità, tale da creare legami
ereditari che vanno al di là della pace e della guerra; “affinché anche quando
vivrai allora nella terra dei tuoi padri , curi il mio ricordo, perché a me per
prima devi la mercede (zoagria) per
la salvezza della vita.” Nausicaa chiede ad Odisseo, il naufrago, di rendere
con la rinnovata vita presente testimonianza della propria vicenda umana di
caduta e di salvezza, di dolore e di ritrovata fortuna. Nausicaa, rispettando
la legge divina ed umana, etica e civile, ha permesso la salvezza di Odisseo:
la ricompensa (zoagria) che le spetta
è il ricordo, monumentum, nel
pensiero e nelle parole, affinché gli uomini riflettano e capiscano.
“L’ospite ed il supplice sono come un fratello per
l’uomo che pur poco sfiori il senno.” (θ, 546-7): così afferma l’epos, in
attesa che un’altra Parola risuoni forte nel mondo.
( zoagria
è un termine tecnico che i traduttori omettono ma che, a mio avviso, è
essenziale per comprendere il significato dell’episodio)
Salvatore Daniele
Aggiunto il 16/08/2013 16:29 da Salvatore Daniele
Argomento: Filosofia delle idee
Autore: Salvatore Daniele

“Una situazione del genere è meglio farla gestire a qualcuno che ha più esperienza” è una frase molto ricorrente ne vocabolario comune: indica la capacità di un soggetto A (usufruendo della scri

Era il 21 settembre del 1860, quando a Francoforte un anziano uomo di 72 anni moriva a causa di una malattia polmonare. Probabilmente, fu per lui una liberazione; aveva sempre sostenuto che era m

Che cos’è la filosofia? I manuali di storia della filosofia ed i dizionari filosofici ne danno diverse definizioni, in parte elencando significati storicamente dati da diverse scuole attive nel