- Accedi
- Registrati
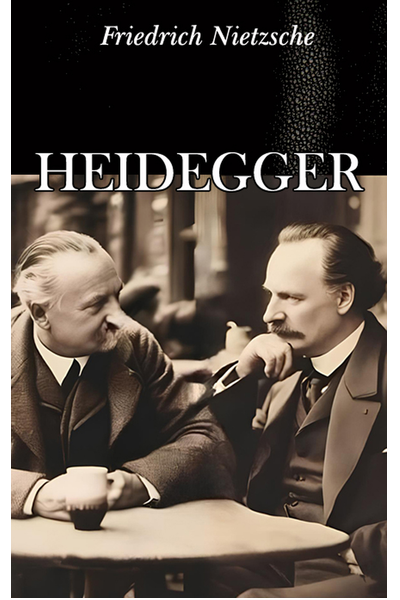

La filosofia moderna e contemporanea: dal Romanticismo all'Esistenzialismo
29,92 €
La filosofia antica, la patristica, la scolastica

Dalla crisi della modernità agli sviluppi più recenti
13,50 €
Da Schopenhauer alle nuove teologie
51,60 €
Dalla Grecia antica ad Agostino
22,40 €
Convivere con lo straniero
23,66 €
Il pensiero contemporaneo
22,40 €
Da Schopenhauer a Freud
48,75 €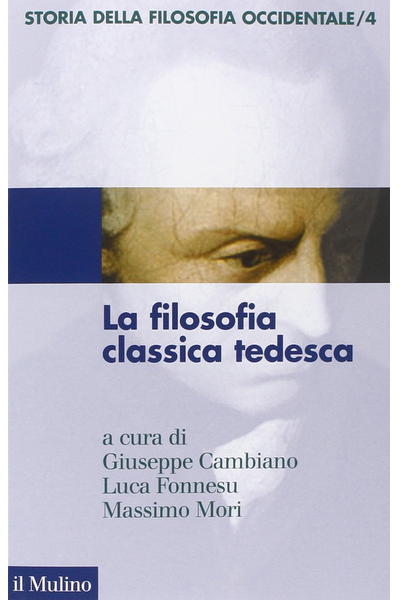
La filosofia classica tedesca
17,60 €Introduzione generale alla Scuola di Francoforte
di Davide Orlandi
La Scuola di Francoforte riunisce autori tedeschi ebrei a partire dagli anni ’30 e ’40 del '900 che insieme elaborano una teoria critica. Ci sono personaggi come Adorno, Horkheimer, Mancuse, Benjamin, Fromm, Krakauer. Soprattutto Adorno vede nella concezione della storia come storicità esistenziale il rischio di fare direttamente dell’esistenza un’essenza, cioè di ontologizzare l’ontico, essenzializzare l’esistente. Il rischio implicito dell’essenzializzazione dell’esistente, magari anche solo per salvarlo, per dargli un senso, come in Heidegger; fa sì che sopraelevare immediatamente (senza soluzione di continuità) l’esistente all’essente finisce per cancellarlo: fa evaporare la materia storica concreta, reale. Si passa dalla storia alla storicità. Il rischio di essenzializzare l’esistente, dice Adorno, è di “trasporre lo storico in invarianza, senza riguardo al nucleo storico dello stesso contenuto di realtà.” (Adorno, “Note per la letteratura”) C’è un legame tra la storia e l’essere, tra storia e verità, a cui si fa torto quando si fa prevalere l’essere e la verità sulla storia. Il rischio è di far evaporare la materia storica, cioè di perdere ciò che nella storia vi è di transeunte, di deperibile, di caduco. La storia è anche questo, non è solo qualcosa di immediatamente guadagnato al senso. C’è qualcosa che resiste nella storia ad una comprensione totalizzante, la mette in discussione, apre e riapre continuamente la questione del senso. Allora il rischio è inchiodare la storia all’immobilità di un eterno presente. Se c’è un’eternità, va ricercata e custodita nell’elemento storico, nelle articolazioni fragili, nei punti ciechi del reale; in qualcosa che non è mai assimilabile al pensiero. L’illusione del pensiero è di guadagnare tutto a sé, c’è qualcosa che invece resiste a questo tentativo. Adorno riprende una frase di Karl Krauss secondo cui “bisogna porgere orecchio ai rumori del giorno come se fossero gli accordi dell’eternità”. Se c’è qualcosa di eterno, si dà solo qui. È proprio il carattere storico a rendere gli elementi della realtà insuperabili, non fagocitabili, assorbibili dal pensiero, che è l’unico interlocutore che possa in qualche modo procedere ad una comprensione della realtà. Il problema è che il pensiero è anche il principale nemico della realtà perché il rischio è in un suo eccesso. Il pensiero eccede quando presume di poter tradurre il reale nel pensato, l’impensabile nel pensato. C’è qualcosa che non si chiude entro catalogazioni concettuali. La storia è quel materiale difficile da gestire perché una volta che tu hai completato il tuo percorso di pensiero ti accorgi che la storia è qualcosa che è rimasto fuori. Anche se l’intento è buono (costruire un sistema di modo da non perdere nulla della storia) questo tentativo è ciò che fa perdere la materia storica: nella storia c’è qualcosa di irrazionale, di misterioso così come irrazionale e misterioso è l’uomo. Bisogna guardare con l’occhio destro, cioè con criticità, le evidenze e le essenze dei fenomeni. Dopo Husserl arrivano gli “eretici” della fenomenologia (Merleau-Ponty, Ricoeur, Lévinas, Marion) che mettono in discussione questa visibilità totale. Marion parla dello sguardo dell’uomo: quando noi guardiamo un altro, l’altro ci guarda attraverso un punto oscuro, la pupilla, in cui non vediamo nulla: questo per esprimere come ci sia un fondo di non pensato, di non dicibile, di non trascrivibile nei termini del pensiero che resta e sollecita il pensiero a continuare a pensare; ma che non si fa padroneggiare.
Difendere la materia storica nella sua effettività, come superficie non agevole, non significa rinunciare ad un significato anche universale della storia. Il pensiero filosofico si misura sempre con ciò che non può pensare, sennò è un’altra forma di pensiero. Sicuramente il filosofo della storia interroga la storia per cercare un significato: Adorno dice che bisogna pensare insieme storia universale e discontinuità. La discontinuità fa saltare sempre e continuamente quella presunta universalità ma lo sforzo è di arrivare ad una comprensione condivisibile universalmente. Per Adorno la storia deve essere unione di continuità e discontinuità. Questo va tenuto fermo. Qual è il rischio implicito nella rinuncia a priori di un significato universale della storia? Si rischia di dare credito solo alla mera fattualità. Se noi rigettiamo come residuo metafisico il senso ci buttiamo nelle braccia dell’altra sovranità: quella del fatto. Non ci sarebbe filosofia della storia: emergerebbe il pragmatista (Dewey). Ci sarebbe una resa all’ordine di cose così come sono. Poiché sono, valgono in quanto sono. Il diritto è nel farsi, nell’essere fatto. Quando contestiamo il primato prepotente dell’idealità nella lettura della storia, con questo non vogliamo dire che ci affidiamo alla fattualità, che di per sé non esiste nemmeno. Nella filosofia della storia non ci sono mai termini a sé stanti: l’idea, il fatto. Questa è un’astrazione. C’è solo la loro relazione, il loro intreccio. Il fatto è ciò che c’è perché viene letto teoricamente, la teoria c’è perché viene confermata fattualmente. Assomiglia a Vico: inverare il certo e accertare il vero. Per Vico il certo sono i fatti. Noi incontriamo il certo. Rispetto al certo c’è il vero che è l’idealità. Accertare il vero vuol dire tradurre nei fatti quell’idealità, quella verità. Inverare il certo = riconoscere in quei fatti quella stessa realtà. Non si dà uno senza l’altro. Se io resto solo al certo o solo al vero, manco il bersaglio: la realtà si dà solo nell’intreccio del fattuale e dell’ideale. Non ci si può affidare ad una sovranità perché non ci sono sovrani. E la sovranità è sempre feticistica. È il feticismo del fatto: il Fatto. I fatti parlano. Oppure: l’Idea. È l’Idea ciò che conta. NO, sono scelte parziali che mancano il bersaglio perché la realtà è fatta dal loro intreccio.
Horkheimer se la prende con Dewey che è il nome di riferimento del pragmatismo. Horkheimer ne parla in “Eclisse della ragione”. Per Dewey – secondo Horkheimer – per raggiungere la chiarezza nel pensare dobbiamo limitarci a considerare gli effetti pratici di ciò che facciamo. Questo non ci accontenta. È un agire avvalorato dalle sue conseguenze mentre l’azione autentica che è una azione che non possediamo, pur essendone gli autori, quindi non ne possediamo le conseguenze. Un’azione autentica può essere autentica, vera e arrivare a degli effetti pratici fallimentari. Questo non esclude che l’azione sia autentica. Se noi misuriamo le azioni solo dalla loro efficacia, ci leghiamo ad una logica consequenziale. È buono, è vero; solo ciò che ha un effetto. Quante cose vere e ideali non hanno effetto o hanno un effetto opposto? Quante volte sentiamo lo slancio di dire qualcosa, di prendere una parola per comunicare qualcosa che ci sta a cuore, che ci anima e quel messaggio viene frainteso, equivocato? Ciò non toglie che l’azione sia autentica e ci vuole coraggio per cominciarne una. Prendere la parola, iniziare un discorso: è un’azione autentica. Noi siamo abituati ad una concezione volontaristica del soggetto: io, dotato di volontà, decido di fare questo, poi quello e poi quell’altro. Questo è da smantellare. Il soggetto, nella sua autenticità, è agito: è agente perché se non c’è lui l’azione non si dà, ma non possiede l’azione. Scrivere di filosofia, ad esempio: tu hai l’esperienza entusiasmante di fare qualcosa che di colpo accade. È l’evento: tu sei l’unica persona che può dare vita a quella cosa lì, ma è una cosa che ti trascende. Così chi fa musica: non è padrone di ciò che sta facendo, ma è padrone e spettatore di questa cosa che accade. Accade non è un verbo a caso: accade non ha soggetto. Quella cosa accade grazie a me, ma va al di là della mia pianificazione. Quello che accade nel momento della creazione si produce con un salto. Non c’è una sequenza logica. Accade che viene fuori un’idea, che non sarebbe potuta venir fuori senza i passaggi precedenti ma che non dipende da tutti quei passaggi: non è un risultato ma è un passaggio a lato che non prevedevi ma si dà. L’esperienza della verità è questo: è qualcosa che si dà.
Qual è la realtà storica che scompagina i piani del pensiero, che non si fa metabolizzare dal pensiero filosofico e che quindi interessa al pensiero filosofico della storia? Quella che è da inseguire con lo sforzo della nostra comprensione è la storia del dolore patito. La storia non ancora raccontata e forse non raccontabile fino in fondo riguarda, per il filosofo della storia, la vicenda dell’elemento represso, escluso, scartato, marginalizzato. Il dolore è collegato alle vicende del ‘900 ed è un elemento che mette in crisi la filosofia perché non si fa guadagnare al senso come una contraddizione logica (Hegel). C’è qualcosa di negativo e io riesco a renderlo produttivo di uno svolgimento ulteriore verso una positività superiore. Con la contemporaneità si fa esperienza del fatto che c’è un male, c’è un dolore che resta lì. Fa resistenza e non si fa recuperare al senso: rimane lì muto e silenzioso. Mette in crisi la filosofia anche perché nel nostro mondo il dolore, la sofferenza, cioè ciò che può provare l’elemento represso, viene negato. Non si sta parlando della spettacolarizzazione del dolore catartico (uscire dal cinema e piangere perché il film ci è piaciuto tanto, ci ha fatto scaricare delle emozioni). Noi viviamo in quest’epoca di spudoratezza del dolore (es.: video e immagini di Morosini) che provoca un lutto immediato perché colpisce l’emotività. Morosini ormai non se lo ricorda quasi più nessuno perché l’emotività è labile e veloce: viviamo di emozioni, passata una ne arriva un’altra, siamo bombardati da emozioni continue. Questa è una maniera per narcotizzarci rispetto al dolore: ci abituiamo a vedere il dolore rappresentato. Il pensiero che cerca di fare filosofia tenendo conto del dolore, dell’elemento represso fa qualcosa che non è questo: cerca di restare al dolore, di impedire quel flusso continuo per cui c’è quell’imput di quell’immagine che ti sconvolge ma per cinque minuti. Di queste cose così veloci non abbiamo esperienza, non facciamo in tempo ad assimilarle.
Qual è l’elemento represso? Come emerge leggendo “Dialettica dell’Illuminismo” innanzi tutto la natura, in tutte le sue forme, non solo quella paesaggistica, quindi anche la naturalità umana; poi la corporeità, la follia. Queste sono tutte figure della differenza, figure marginalizzate nel nostro sistema di sapere moderno.
L’esperienza della storia del ‘900 parte e resta alla negatività. Il ‘900 è un secolo in cui la negatività ha avuto un effetto deflagrante. La negatività si è prodotta anche come collasso del rapporto tra ragione e storia. Non si riesce più a capire quale efficacia abbia la ragione nella storia, anzi si mette in dubbio che ci sia una ragione nella storia. Inoltre produce un collasso nel rapporto tra l’esperienza e il suo senso. Il problema della storia oggi, per come noi la conosciamo, nelle sue realizzazioni e nei suoi devastanti fallimenti; è che non si fa più abbracciare da un unico sguardo, da un’idea presa a prestito dalla teologia. Questa storia respinge il tentativo di agganciarla ad un’idea o di chiuderla in un assoluto totalizzante. C’è una crisi del senso storico che consiste nella difficoltà di ordinare in una sequenza significativa i fatti e le esperienze. I fatti perché non sono più quelle realtà compatte come noi le pensavamo e le esperienze perché non siamo più capaci di un vero esperire. Non riusciamo più a raccontare cosa ci è successo. C’è un black-out: non si riesce più a raccontare cosa ci è accaduto. Questa diagnosi non è così contemporanea ed attuale: già Benjamin nel 1936 nel saggio “Il narratore” (compreso in “Angelus novus”) scrive sull’incapacità dell’avere esperienza e dice: “capita sempre più di rado di incontrare persone che sappiano raccontare qualcosa come si deve. È come se fossimo privati di una facoltà, che sembrava inalienabile, la più certa e sicura di tutte, cioè la capacità di scambiare esperienze. Una causa di questo fenomeno è evidente: le azioni dell’esperienza sono cadute. Con la guerra mondiale cominciò a manifestarsi un processo che da allora non si è più arrestato: non si era visto che alla fine della guerra la gente tornava dal fronte ammutolita, non più ricca ma più povera di esperienza comunicabile?”. C’è quindi una difficoltà nel raccontare ciò che è successo. Il racconto è alla base del consolidarsi dell’esperienza. Sembra che oggi, con l’aumentare delle prove, il testimone non sia più capace di riportare fedelmente ciò che ha visto. C’è uno scollamento tra ciò che esperisco e la facoltà di chiamarlo per nome.
Si sono frantumati i grandi orizzonti di leggibilità dell’esperienza. È caduta l’idea del grande racconto della storia che non si dà più in un grande racconto. Bisogna però dire che si sono distrutti dei miti e delle illusioni. Ad esempio: il mito assoluto e alla fine statico del progresso. L’esperienza contemporanea fa pensare che anche il progresso progredisca. Sembra che anche il concetto del progresso, in base alle sue realizzazioni e ai suoi fallimenti, debba essere ripensato in maniera storica, cioè alla luce della sua storia. Cosa vuol dire progredire oggi? In che direzione andare? Continuare sempre avanti in una crescita illimitata o tornare un po’ indietro, che sarebbe un progredire qualitativo? La realtà ce lo fa capire. Le risorse sono finite, il fatto che un giorno finiranno è un dato di fatto. Questa necessità impone la virtù (di necessità virtù, come dice Kant): quello che l’uomo con la sua libertà non vuol fare lo farà costretto dalla natura, che voglia o non voglia. La natura dà l’orientamento per un comportamento virtuoso. Occorre assumere un modus vivendi commisurato alle nostre capacità: abbiamo un numero limitato di giorni di vita e dobbiamo viverli al meglio. La necessità è il limite all’interno del quale puoi avere uno svolgimento virtuoso e realizzare la tua libertà.
Resta aperta la domanda sull’uomo, sulla sua natura; sull’esigenza di dare un orientamento alla propria vita, con lucidità, con un certo disincanto rispetto ai miti del progresso e della totalità. Progresso e totalità sono le parole bersaglio colpite dai francofortesi.
La Scuola di Francoforte e i suoi temi
I due autori che costituiscono i punti di riferimento principali sono Adorno e Horkheimer. Del gruppo fanno però parte anche Benjamin, Marcuse e Fromm. La Scuola di Francoforte è il termine sintetico che indica l’Istituto per la ricerca sociale di Francoforte, fondato nel 1923 come Istituto privato, poi affiliato all’università di Francoforte. Sotto la direzione di Horkheimer a partire dal 1929 l’Istituto conosce la sua migliore stagione e sviluppa quelle tematiche che caratterizzano la scuola per come noi la conosciamo oggi. L’atteggiamento generale che contraddistingue le loro analisi è un atteggiamento critico. I temi fondamentali sono:
Una teoria della società. La società è pensata come un tutto ed è analizzata da diverse prospettive (psicoanalisi, antropologia, economia, sociologia, filosofia).
Questo carattere interdisciplinare caratterizza anche i singoli autori della Scuola di Francoforte: sono personalità poliedriche, ricche di contaminazioni: Horkheimer si interessa in maniera approfondita di psicologia e Adorno è musicista, musicologo, saggista, sociologo, filosofo.
Rapporto tra la società e l’industria culturale. Per industria culturale si intende il sistema di produzione della cultura come prodotto commerciale, come bene di consumo. L’ industria culturale rappresenta per loro la mercificazione della vita intellettuale e spirituale. Tale critica ha diffusione negli anni ’60 del '900 e si concentra soprattutto sulla produzione dei mass media e interessa anche cinema, radio, pubblicità, rotocalchi e televisione. L’idea che soggiace a questa critica è che i mezzi di comunicazione di massa facciano introiettare all’individuo il sistema esistente di valori o di disvalori della società, spegnendo lo spirito critico. Il loro compito è diffondere un’immagine del mondo che sia accettata da tutti, è quello di diffondere un linguaggio uniformato, un pensiero unico. In questo diventano strumento di manipolazione delle coscienze. Ricordiamo che in quel momento non c’è ancora internet, quindi ora è volendo ancora peggio.
In questo quadro apocalittico e pessimistico ricordiamo però che la loro concezione dell’uomo non è così pessimista. Non pensano che l’uomo sia un essere animale aggressivo che deve scaricare sugli altri la sua aggressività. Pensano invece che l’uomo abbia in sé delle risorse, una positività. Allora è fondamentale la critica al prodotto umano: lì si verifica la deviazione, l’aberrazione e il fallimento.
la critica della scienza nelle sue applicazioni tecnologiche che non sono strumenti neutrali ma possono diventare lo strumento di dominio dell’uomo sull’uomo. Si critica il metodo delle scienze naturali e positive, che accusano di un approccio meccanicistico alla realtà, insufficiente a leggerla. Horkheimer nel 1932 in Teoria critica dice che l’approccio scientifico intende la società come una macchina, in maniera statica; mentre bisogna considerare la realtà come un divenire e la società come qualcosa di dinamico, dialettico, contraddittorio, soggetto a convulsioni. Questa è la realtà con cui il pensiero critico si confronta. Consideriamo che queste cose vengono scritte nel periodo della grande crisi del 1929. Vivono un periodo di crisi quasi pari a quello che stiamo vivendo noi. Quasi tutti gli autori sono marxisti ma si distinguono da questo punto dal marxismo perché a differenza del marxismo classico che sosteneva la neutralità della scienza rispetto al proletariato e riconosceva alla scienza un elemento utile per il progresso della civiltà umana; per Horkheimer la scienza è sempre forma di dominio. Questo è ribadito da Lukács in “Storia e coscienza di classe” ed è espresso inoltre nella “Dialettica dell’Illuminismo”.
l’esigenza di liberazione che tutti gli autori esprimono. È possibile perché ciò che accade non è necessario ma è il prodotto di uno svolgimento storico e va sottoposto a critica. Quali sono i soggetti di liberazione? Gli intellettuali non conformisti (loro si riconoscono in questa responsabilità) e gli emarginati, gli oppressi: tutte quelle figure scartate dalla società del progresso.
Il profilo culturale di questi autori è complesso e pieno di riferimenti impliciti. Adorno è un autore difficile perché ha una cultura sterminata. Il suo stile si sottrae ad una facile percorribilità perché è uno stile paratattico con tante coordinate e poche subordinate. La subordinazione, nell’argomentazione logica, ci dice cosa è importante e cosa invece è subordinato. Adorno invece propone argomenti tutti egualmente importanti.
Di questa fisionomia composita degli autori francofortesi si dà un’immagine che è quella della costellazione, proposta ad Adorno ma ripresa da Benjamin. È una metafora astronomica che indica un gruppo di elementi mutevoli non integrati: ci sono tanti elementi che insieme compongono una costellazione ma che non sono integrati in un sistema e non si riconducono ad un comune denominatore, ad una identità. Non c’è un rapporto gerarchico né una riconduzione all’unico, all’identico. L’identità è una delle categorie smantellate sistematicamente dagli autori francofortesi. È una Scuola in cui discutono insieme e tra l’altro scrivono insieme, cosa abbastanza rara.
Caratteristiche della Scuola di Francoforte (parte 2)
L’immagine della costellazione ci è utile perché nella Scuola di Francoforte è tutto collegato. Si parla di questa immagine per intendere la concezione dell’identità non identitaria che questa scuola persegue. Il nemico numero uno del pensiero critico è l’Identità, il Medesimo. La costellazione è una alternativa all’identità: dà l’idea di un insieme di elementi mutevoli, non integrati ma che hanno relazione tra di loro; sottraendosi però alla riduzione di un termine unico. Sotteso a questo discorso introduttivo è il motivo dell’opposizione della Scuola di Francoforte al concetto monolitico di verità. Nell’opera del 1963 intitolata “Tre studi su Hegel” Adorno precisa che una costellazione non è un sistema.
“Il pensiero stesso si presenta come configurazione di momenti che è sempre più e altro che il concetto di insieme dei suoi momenti.” Cioè: il pensiero non si riduce alla somma di quei momenti. Si dà grazie a quella costellazione ma indica anche in questo modo altro. È una compagine che ha in sé qualcosa di sempre imponderabile perché non si esaurisce nella somma quantitativa di quei passaggi. Adorno dice che è molto simile a ciò che succede nella poesia: il riferimento è a “Note per la letteratura”, due saggi (uno del 1965 e l’altro del 1974) in cui Adorno scrive: “la verità di una poesia non esiste senza la compagine di questa (=della costellazione), senza la totalità dei suoi momenti, ma al tempo stesso la verità è qualcosa che oltrepassa questa compagine e non dall’esterno, attraverso un contenuto di verità dato, bensì in virtù della configurazione dei momenti i quali, presi insieme, significano più di quel che la compagine intenda.” Cioè: dice qualcosa di più di ciò che l’autore stesso intende perché la verità non è il prodotto di un soggetto. Bisogna staccarsi dall’idea di un soggetto che tramite una sua deliberazione produca la verità. Questa non è l’esperienza reale del soggetto che pensa: bisogna ricordarsi di ciò che dicevamo a proposito dello scrivere di filosofia. Tu metti insieme tutti i passaggi e lavori per i singoli passaggi ma quello che ne viene non sei tu a produrlo. Questa è l’idea dell’homo faber, l’uomo artigiano che ha una idea in testa e realizza tutti i passaggi per realizzare quell’idea. Questa è un’altra filosofia: qua il soggetto non possiede quell’idea. Se effettivamente, dopo la secolarizzazione, ci siamo sciolti dalla tutela metafisica di una trascendenza, allora dobbiamo fare a meno di quella garanzia. Quando si pensa, non abbiamo stampelle metafisiche teologiche.
Parliamo dei punti che costituiscono la costellazione delle idee che danno insieme la figura della Scuola di Francoforte:
Il neo-marxismo, quella tradizione eterodossa inaugurata da Lukács con “Storia e coscienza di classe”, testo del 1923.
La concezione della società e della storia propria del marxismo è il materialismo storico o materialismo dialettico che ha per oggetto le condizioni materiali della realtà sociale e della storia. La storia è l’orizzonte ultimo per comprendere l’uomo e la società. Rispetto a questa concezione, propria del marxismo, la critica interna al marxismo interviene su alcuni punti:
La dissociazione del materialismo dialettico da una dottrina dell’evoluzione applicata alla società.
Era stato Engels intorno al 1870 a creare questo collegamento tra materialismo e evoluzionismo perché era importante arginare il materialismo volgare, statico, meccanicistico e quindi ci si voleva rifare ad una concezione scientifica che tenesse conto della realtà come divenire. Qual è il rischio del collegamento? Il rischio di collegarsi ad un positivismo evoluzionistico consiste nel fatto che si arrivi a concepire la storia secondo un certo determinismo. Un fenomeno storico viene deterministicamente ricondotto alla struttura economica di cui è espressione: c’è un modello scientifico che collega in modo necessario ogni sovrastruttura (arte, religioni, filosofia che sono espressione della struttura economica delle varie formazioni sociali) alla struttura. Ora, questo va bene però non bisogna trovare un rapporto di causa e di effetto diretto perché elimina la libertà: si tende a dire che tutto ciò che è spirituale non sia che la maschera dei rapporti economici. Questo non basta più, non è sufficiente per spiegare le espressioni spirituali dell’uomo.
Il rischio poi soggiacente all’evoluzionismo è di arrivare a prospettare un macro-sistema impersonale e senza soggetto. Ci sono delle leggi che determinano il fatto che certi fenomeni si colleghino in maniera necessaria a delle strutture economiche. Così il soggetto passa in secondo piano: tu sei determinato a produrre certe idee a partire dal tuo radicamento sociale, dalla tua provenienza.
Allora per il neo-marxismo si tratta di eliminare questo collegamento necessario e tornare al soggetto con le sue capacità sociali, storiche, individuali, collettive, politiche. Lukács torna alla dimensione centrale del soggetto e all’importanza della coscienza storica.
Si difende il debito che il marxismo aveva nei confronti della società classica cioè di Hegel.
Di Hegel che cosa è importante tenere? La dialettica e la centralità della teoria. Qual è la posizione invece propria del marxismo? Quella che ha denunciato la teoria e per impazienza di cambiare il mondo ha preteso di trasformarlo prima di comprenderlo, rinunciando allo sforzo critico. Si tratta di tenere e rilanciare entrambe le voci: hegelismo e marxismo. Entrambi puntano sulla dissociazione tra teoria e prassi. Puntano cioè o sull’una o sull’altra. La Scuola di Francoforte ha chiaro questo: non si possono dissociare teoria e prassi. Solo insieme si può comprendere qualcosa. Questo è importante per una filosofia della storia. Sono quei termini che la storia del pensiero ha dissociato: o universale o individuale, o concreto o astratto, o il fenomeno o il noumeno. Il filosofo della storia sa che la dissociazione non funziona: le interpretazioni che usano solo uno strumento (o teorico o pratico) falliscono nella comprensione della realtà. Bisogna tenere entrambi.
Soprattutto Horkheimer si scaglia contro la degenerazione del marxismo e denuncia il fatto che la sua applicazione storica l’abbia ridotto ad una serie di formule morte. È una dottrina che ha abbandonato il suo impulso rivoluzionario e perciò anche la volontà di cambiare il mondo finendo per adattarsi alla realtà esistente. Il seguente è un punto ricorrente nella Scuola di Francoforte: i concetti sono materia viva, vivente. Quando si formalizzano, diventano idoli. Si cade nel feticismo del concetto. Ogni dottrina è vera fino a quando non si fossilizza in un dogma. Il pensiero critico cerca di non chiudere mai il discorso in una definitività. Perché il discorso non può essere chiuso? Perché la realtà continua a muoversi quindi risulta infedele alla realtà un pensiero che decide di fermarsi ad un certo punto.
Il pensiero critico è quello che pensa criticamente anche a sé. Quando il pensiero perde questa auto-criticità si blocca nell’affermazione che è la fine del pensiero.
Il marxismo dei francofortesi è un marxismo sui generis: questi autori utilizzano la dottrina del marxismo come strumento per l’analisi e la critica della realtà. Dopodiché danno forma a pensieri così personali e liberi da qualsiasi appartenenza al punto che si fa fatica a collocarli dentro al marxismo. C’è un uso strumentale: noi prendiamo tutto ciò che ci serve per pensare meglio alla realtà, non abbiamo delle appartenenze.
Messa in questione della concezione ascendente della storia
Cioè lo schema dell’inevitabile progresso della storia dell’umanità. Tutti questi autori si oppongono all’ideologia e al mito del progresso perché proprio i luoghi di eccellenza del progresso (avanzamento tecnico e scienza) dimostrano come quegli stessi successi siano i luoghi della degenerazione e del fallimento della storia umana. In questo sono vicini all’analisi che fa Husserl nella Krisis. È singolare che Husserl scriva la Krisis nel momento dell’apice del successo della scienza, anticipando quelle che sono state le successive conseguenze negative. C’è già una negatività che si legge nel momento in cui l’uomo sta accogliendo i frutti di quel successo. Quello che sembra un successo per tutti – dice Husserl – è in realtà l’ottundimento di fronte alla realtà. Gli uomini vivono già in una situazione di crisi ma non lo sanno: manca quello sguardo vigile che fa riconoscere qualcosa che è storto fin dall’inizio. Continuiamo a godere dei benefici che la scienza ci dà senza capire che c’è una stortura all’inizio di quel rapporto. È ciò che poi, oltre ai vantaggi, procura una degenerazione nel rapporto dell’uomo col mondo. Abbiamo una macchina che funziona ma di cui non capiamo più il funzionamento e che accettiamo passivamente: questo indica come l’uomo si sia allontanato dalla consapevolezza. Pensiamo alla burocrazia: c’è un insieme di persone in cui nessuno ha la responsabilità e questo permette però di trattarti come un pacco da passare in ufficio in ufficio. Si pensa allora che ci siano delle regole a monte a cui dobbiamo affidarci e verso cui siamo impotenti. Il problema è che però forse quelle regole non esistono: è un sistema che si regge sulla dispersione della responsabilità e che non porta nessuno ad essere responsabile.
Il conservatorismo culturale oligarchico (=governo di pochi illuminati). Conservatorismo non è in contraddizione con le inclinazioni marxiste e moderniste di questi autori ma si rivolge contro gli aspetti degeneri della modernizzazione, cioè contro la cultura di massa, il dominio della burocrazia, la ragione strumentale e tecnica (=funzionale a, pragmatica). Il conservatorismo culturale oligarchico rimanda ad una idea di cultura che non sia quella di massa. È chiaro che non molti, se c’è la massa che segue una certa cultura, saranno fuori da questa massa. Non c’è una superiorità vantata da parte di questi autori. C’è però quella considerazione per cui c’è una cultura di massa che come un grande blob sta omologando, spingendo verso un pensiero e dei bisogni unici. Allora loro ci mettono in guardia dicendoci che siamo tutti dentro ad un grande brodo che però non è cultura. C’è una contestazione romantica da parte di questi autori (ma anche da parte di Marcuse e Benjamin), una sorta di anticapitalismo romantico. Romantico non è nostalgia, questi autori sanno che indietro non si torna. Non è possibile ritornare ad una origine, un passato idilliaco in cui tutto funzionava. Non si vagheggiano comunità primitive: non si torna alle foreste e non è possibile un ritorno. Al limite è possibile una ripartenza per cui si stabilisce un inizio e un nuovo cominciamento (ecco l’azione libera). Indietro non si torna: la storia ci insegna l’irreversibilità. Ciò che si è dato, si è dato. Bisogna accettarlo, anche perché solo accettando di essere in una certa società, in un certo contesto con certi problemi possiamo intervenire in maniera utile. C’è però questo mito dell’origine: fa pensare che all’inizio fosse tutto positivo, in realtà Nietzsche insegna che all’inizio c’era la barbarie. Anche Vico ce lo dice. Bisogna smitizzare queste cose.
Altro tema, affrontato soprattutto da Horkheimer, è il rapporto tra marxismo e psicanalisi.
È una commistione molto difficile perché si tratta di far interagire delle categorie e dei concetti di carattere socio-economico con categorie e concetti che difficilmente si adattano alle precedenti come le pulsioni istintuali della vita psichica inconscia, che non si fanno inquadrare direttamente all’interno di una lettura socio-economica. Sono coordinate apparentemente incompatibili che il filosofo riesce a fare interagire. Per Horkheimer e Adorno c’è un primato che va riconosciuto alle categorie socio-economiche, cioè alle condizioni materiali di produzione e riproduzione della vita umana. Questo va d’accordo con l’adagio “primum vivere deinde philosophare”, cioè prima bisogna vivere e poi si fa filosofia. È un approccio condiviso da Adorno anche rispetto alla questione del male. Questo autori affrontano in diversi luoghi il problema della negatività e del male ma non si trova mai nelle loro analisi una riflessione metafisica sul male: non si cerca mai di spiegare il male secondo delle ragioni ontologiche o metafisiche. Adorno dice: cominciamo a capire le condizioni effettive, congetturali, reali, storiche in cui si è prodotto il male e cominciamo ad eliminare tutte le condizioni materiali che hanno fatto sì che l’uomo avesse bisogno di fare il male. Il problema è che il male torna ancora utile, serve ancora a qualcosa: lo scopo non è abbattere il male ma creare le condizioni storiche in cui non ci sia bisogno di fare il male. Una volta eliminate queste condizioni allora uno può riflettere sul male in sé, nella sua origine oscura ed inspiegabile. Però prima guardiamo cosa possiamo fare per evitarlo. C’è un approccio illuministico in questo: anche l’Illuminismo non si perde in riflessioni molto profonde sulla negatività ma pensa al perché l’uomo si è trovato nella situazione di dover compiere il male e individua lì una responsabilità. Spesso il ricorrere a delle spiegazioni metafisiche nasconde una irresponsabilità nei confronti del male.
Allora consideriamo le condizioni socio-economiche della realtà. Horkheimer dice che la psicologia del profondo permette di capire come gli individui non si riducano a semplici rapporti economici: hanno una vita psichica comprendendo la quale si comprende l’andamento della storia e il motivo per cui gli individui, per un bisogno di sicurezza, di integrazione, sono pronti ad accettare dei sistemi politici gerarchici, autoritari e contraddittori. È importante capire la psiche per spiegare come mai il totalitarismo abbia avuto così successo. Horkheimer si rifà alla distinzione freudiana tra impulsi non differibili e impulsi differiti. I primi sono quelli fondamentali: fame, sete ecc., quelli legati all’istinto di autoconservazione. I secondi sono impulsi sessuali o libidici. Per Horkheimer gli uomini non sono condizionati solo dal loro immediato istinto di autoconservazione e non sono spinti, mossi ad agire solo per rispondere ad esso ma sono mossi dall’esigenza di esprimere le proprie energie libidiche: hanno bisogno che la loro personalità venga riconosciuta e confermata all’interno di una collettività. Il legame tra vita materiale e psichica è complesso e da questa connessione dipende anche la stabilità relativa di un ordinamento sociale: non si spiega una società solo attraverso i rapporti economici. C’è una parte intima, personale, soggettiva ma in realtà è una parte correlata all’altra e la determina anche.
Ad interessarsi di psicanalisi è anche Fromm, che scrive “Avere o essere?” nel 1976. Anche lui utilizza la psicanalisi ai fini dell’indagine sociale. Si ricorda Fromm perché non accetta un punto della dottrina freudiana: non accetta il fatto che le pulsioni erotiche siano indisgiungibili dalle pulsioni distruttive. La critica anche pessimistica della scuola di Francoforte colpisce l’esistente ma a differenza di Freud difende una radicale positività della natura umana. Freud associa immediatamente i due impulsi (eros e thanatos) e in questo modo getta un pesante carico di aggressività e di negatività sulla natura umana. Questo pessimismo gli autori francofortesi lo riconoscono nel processo storico, nell’apparente procedere del progresso ma non nella natura umana: non è un carattere suo proprio. Freud, “Disagio della civiltà”, 1930: “non è affare mio la critica economica del sistema comunista. Non posso sapere se l’abolizione della proprietà privata sia opportuna e produttiva ma sono in grado di riconoscere che la sua premessa psicologica è un’illusione priva di fondamento. Con l’abolizione della proprietà privata si toglie al desiderio umano di aggressione uno dei suoi strumenti. L’uomo non è una creatura mansueta, bisognosa di amore, capace al massimo di difendersi se viene attaccata ma occorre attribuire al suo corredo pulsionale anche una buona dose di aggressività”. Da questa concezione si dissociano i francofortesi. Freud pensa che l’uomo vede nel prossimo non solo un eventuale oggetto sessuale o un aiuto ma anche un bersaglio per scaricare la sua costitutiva aggressività: può sfruttare la sua forza lavorativa senza ricompensarlo, può abusarne sessualmente, può sostituirsi a lui nel possesso dei suoi beni e può aggredirlo. È la concezione dell’homo homini lupus. Questa non è la concezione dei francofortesi che non condividono quest’idea di un’ostilità fondamentale dell’uomo contro l’uomo. Per loro l’uomo è un essere sociale che si realizza nella socialità. Pensano che una società armonica sia possibile: questo a partire dalla premessa fondamentale per cui l’uomo non è in sé un lupo.
Il modernismo estetico. Molti si occupano di estetica, specie Adorno che ebbe diretta esperienza dell’avanguardia musicale viennese. Fu allievo per diversi anni di Alban Berg. Fu compositore lui stesso. I suoi scritti giovanili sono di critica musicale. La poliedricità di Adorno ha in sé una intima coerenza: anche questo interesse per la musica è coerente, per il suo contenuto, con ciò che abbiamo detto sull’identico e sulla costellazione. Adorno è interessato alla musica atonale (Alban Berg, Schönberg) che è una rivoluzione delle tecniche tonali. L’atonalità si contrappone alla tonalità nella quale diverse aree tonali si collegano tutte alla stessa nota che è detta tonica. Nella musica atonale esplode questo collegamento: non c’è più quel collegamento delle diverse note alla nota tonica ma vengono slegati questi schemi, questa riconduzione all’uno, che adesso è rappresentato dalla nota tonica. È l’“emancipazione della dissonanza” (Schönberg): è l’affermazione della non identità. È qualcosa di artistico che è assolutamente coerente col pensiero adorniano, così come è coerente col modo di pensare: è un pensiero che si slega da un garante metafisico unico, non c’è più un garante metafisico, un fondamento. L’interesse per la musica resta in Adorno sino alla fine: l’opera postuma è un’opera di teoria estetica del 1970.
In questa costellazione brilla la stella ebraica: quest’espressione ha un significato immediatamente evocativo perché la stella era il simbolo che veniva messo per contrassegnare gli ebrei. È solo con la tragedia storica dell’olocausto che i francofortesi prendono coscienza di questo retaggio, cioè del fatto di essere tutti ebrei. Fino ad allora per loro non è un problema e non ne scrivono, né ne parlano. Diviene un problema con la tragedia storica. Biograficamente si può parlare di sommersi e salvati. Benjamin muore suicida per sfuggire alla persecuzione nazista: riesce a fuggire in Spagna, dove sperava di ottenere un visto per l’America; gli viene negato per un giorno e nella notte si toglie la vita. Adorno, Horkheimer, Fromm e Marcuse riescono a fuggire in America. Adorno va anche in Inghilterra dove tenta un concorso di dottorato e viene respinto perché non sapeva ben parlare l’inglese e poi perché risultava troppo difficile. Adorno e Horkheimer ritornano dall’America nel 1950 e si stabiliscono a Francoforte dove aprono l’istituto per la ricerca sociale. Altri, come Marcuse e Fromm, rimarranno per sempre negli Stati Uniti. È soprattutto Adorno a scrivere di antisemitismo e indaga il rapporto tra antisemitismo e pensiero totalitario perché comprende come l’ebreo rappresenti il più ostinato depositario della non identità, dell’alterità, della differenza che il totalitarismo aveva cercato di liquidare. In “Dialettica negativa” Adorno dice: “Auschwitz conferma la norma filosofica della pura identità come morte”.
Tutti questi autori si rifanno ai grandi classici: Kant, Hegel, Marx e Husserl. Un ruolo importante nel percorso filosofico di Adorno lo ebbe sicuramente Benjamin (c’è un debito verso Benjamin talvolta nemmeno riconosciuto da Adorno).
Se dovessimo tracciare un identikit filosofico allora diremmo: Adorno è il padre della dialettica negativa e insieme a Horkheimer è il padre fondatore della teoria critica che costituisce quella linea di pensiero come autocritica della razionalità occidentale.
La teoria critica è una teoria capace di riflettere sui propri fondamenti. Due annotazioni preliminari sul significato della teoria critica:
Non è semplicemente una teoria della società ma è propriamente filosofica. Va al di là della semplice descrizione della realtà sociale perché pensa che in quella descrizione sia in gioco una questione veritativa. Non c’è una subordinazione della riflessione filosofica alla prassi: la filosofia non è funzionale a esigenze di ordine pratico. Non basta una lettura sociologica, sicuramente utile ed importante, ma in quanto si trova in rapporto alla questione della verità.
Colui che si propone come pensatore della teoria critica non presume di sapere da che parte stia la ragione. “Minima Moralia”, scritta tra il 1944 e il 1947, quando Adorno è in America, pubblicato in Germania nel 1951. È un testo aforistico famoso, pieno di idee non superate. Citazione: “nulla si addice meno all’intellettuale che vorrebbe esercitare ciò che un tempo si chiamava filosofia che dare prova nella discussione, persino dell’argomentazione, della volontà di aver ragione”. È un po’ l’opposto del temperamento caratteriale di Adorno: non è molto malleabile, ha idee precise e chiare. “La volontà di aver ragione, fin nella sua forma logica più sottile, è espressione di quello spirito di che la filosofia ha il compito di dissolvere”. La filosofia, per come la pensa Adorno, deve andare contro lo spirito di autoconservazione.
Adesso passiamo ad una frase autobiografica, da leggere in modo antifrastico: “quanti filosofi, a cui si sa che il silenzio riuscì sempre difficile, si lasciano trascinare in una discussione…”. Questo è proprio lui: Adorno era un’esplosione di parole, è riferito a se stesso, solo che qua lo proietta al di fuori per criticarlo.
“…dovrebbero parlare in modo da farsi dare sempre torto ma, nello stesso tempo, da convincere l’avversario della sua non verità”. Questo è per ribadire come non ci sia un intento costruttivista nella filosofia di Adorno e dei francofortesi. L’intento è di smuovere le fondamenta di ciò che noi presumiamo dogmaticamente vero. Cominciamo a mettere in discussione tutto, anche loro mettono in discussione, non ne sono esenti, non partono dalla ragione.
La citazione dice
almeno due cose da sottolineare:
A) il filosofo critico non si pone nell’atteggiamento di chi sa già in anticipo la soluzione al problema perché non la possiede. Nessuno di questi autori sa come ricondurre la realtà in crisi ad una sua risoluzione. Questa è la consapevolezza che agisce in un atteggiamento critico. L’intervento critico sa che quella realtà non va: smuovendone l’apparente stabilità è possibile favorire un movimento, contribuire a far emergere un movimento che può portare a qualcos’altro che però non si sa anticipare, non si possiede in anticipo. È l’azione autentica. Il carattere critico del mio pensiero non è giudice tra verità e apparenza: al limite posso dire che l’apparenza è tale solo quando possiedo la verità, il problema però è che tale possesso è escluso. Dell’apparenza e della verità è intessuto anche il mio pensiero. Tra l’altro, io sono dentro a ciò che critico, non vivo in un’oasi felice da cui vedo la realtà in crisi. Sono immerso nella realtà in crisi e il pensiero ha in sé il suo rischio. Non c’è un pensiero santo e buono e un pensiero degenere: il pensiero è di per sé questa commistione. Così come l’azione autentica della Arendt che ha in sé i suoi rischi ma ha anche in sé i rimedi.
I rischi sono:
L’imprevedibilità: il fatto che non potendo prevedere le conseguenze dell’azione posso dar vita a qualcosa di fallimentare.
L’irreversibilità: un’azione una volta fatta è fatta e se è autentica incide sulla realtà.
I rimedi dunque sono:
All’imprevedibilità io rispondo in qualche modo con la promessa, che lega le persone tra loro, lega l’azione alla relazione ad altri e cerca di diminuire quello spessore di incertezza che ogni azione autentica ha.
L’irreversibilità viene in qualche modo guarita dal perdono. La cicatrice rimane sempre ma è guarita col perdono, che è un’altra azione autentica; è qualcosa che scaturisce, viene al di là di te, si dà, è un evento. È una azione autentica perché fa nascere qualcosa di nuovo. La cicatrice c’è, perciò non si torna indietro, ma da lì si riparte.
B) Lo spirito di autoconservazione traduce un pensiero della identità. Ribadisce la volontà del soggetto di mantenersi, di conservarsi: è questa affermazione di sé, fatta per sopravvivere. Un conto è sopravvivere, un conto vivere: per vivere si mette molte volte a tacere lo spirito di autoconservazione. Per salvarsi, ci si può perdere: spesso il filosofo si trova in questa situazione paradossalmente impossibile. L’autoconservazione esprime questo soggetto che volontariamente ribadisce la necessità del proprio rafforzamento: è quell’identità, quel medesimo che il pensiero critico vuole smantellare.
Aggiunto il 10/11/2020 20:24 da Davide Orlandi
Argomento: Filosofia della storia
Autore: Davide Orlandi