- Accedi
- Registrati
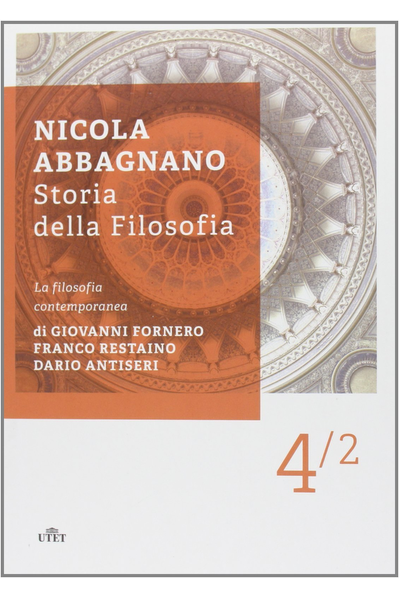
La filosofia contemporanea
30,40 €
I saperi fondamentali che hanno plasmato la società occidentale
20,90 €
Dal moderno al contemporaneo
24,70 €
Dalla crisi della modernità agli sviluppi più recenti
13,50 €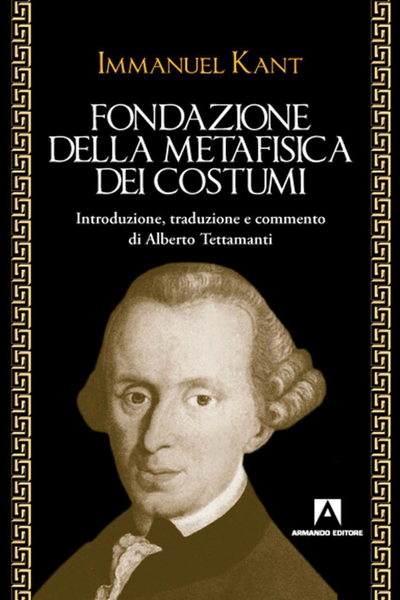
Introduzione, traduzione e commento di Alberto Tettamanti
19,00 €
Romanzo su una indifferibile rinascita dell'umano
6,24 €
Dall'Umanesimo all'empirismo
44,42 €
Teoria ed esercizi
21,75 €
La filosofia antica, la patristica, la scolastica

Medioevo e rinascimento
26,60 €
L'obiezione epistocratica
di Davide Orlandi
Quella dell'epistocrazia, che vorrebbe le sue decisioni tutte fondate sulla competenza, pretesa come assolutamente attendibile, di alcune autorità 1, è una corrente alquanto significativa nell'ambito delle attuali teorie della democrazia deliberativa, ma prima di poter approfondire i moventi, gli sviluppi, e le eventuali repliche all'obiezione epistocratica, è necessario riferirsi all'approccio epistemico alla democrazia deliberativa.
È questo un approccio che vorrebbe una procedura democratica necessariamente obbligata a far riferimento ad uno standard esterno, orientato verso un esito positivo della deliberazione, e che si propone così di rispondere ai detrattori della democrazia, coloro i quali amano in un certo senso ricordare come la folla scelse a maggioranza di salvare Barabba per condannare invece Gesù Cristo, esempio biblico con il quale mi permetto di riassumere la posizione di alcuni critici, persuasi che la democrazia sia un pessimo sistema di governo, sicuro solo nella realizzazione di pessime scelte.
In sintesi, l'approccio epistemico vorrebbe attribuire alla democrazia un valore non puramente strumentale, ma profondamente intrinseco: è convinzione di autori come Estlund e Martì, la cui mira è quella di sottrarre le procedure democratiche a motivazioni basate unicamente su criteri formali, che la giustificazione della democrazia debba essere fondata sulle sue virtù epistemiche, ovvero sulla sua concreta possibilità di produrre decisioni corrette.
Paradossalmente, l'obiezione epistocratica è tanto più insidiosa in quanto non si colloca su un orizzonte opposto, ma anzi si muove proprio sullo sfondo della medesima prospettiva elaborata dall'approccio epistemico, riconoscendo anch'essa come proprio obiettivo quello di identificare la soluzione migliore possibile ad ogni problema, ed arrivando così, partendo proprio da un identico presupposto, ad una coerente giustificazione di un sistema di governo perfettamente opposto a quello democratico.
Se, infatti, si considera che la risposta corretta debba essere l'obiettivo primario da raggiungere nell'ambito di un processo decisionale, e poiché si giudica piuttosto ovvio che ogni membro di una data comunità politica non abbia potenzialmente la stessa facilità di giungere a questa medesima, felice conclusione, appare allora piuttosto intuitivo, per i fautori dell'epistocrazia, adottare come criterio per la distribuzione dell'autorità politica la potenziale capacità intellettuale degli eventuali decisori: la competenza diventa quindi il criterio vincolante per la selezione degli agenti politici, i quali, si può immaginare, si spartiranno il potere decisionale in maniera proporzionale alle singole risorse individuali.
Soluzione, questa, quanto mai simile a quella proposta, a suo tempo, da John Stuart Mill, il quale proponeva di accordare ai cittadini più istruiti, e quindi secondo Mill maggiormente avvantaggiati nel processo d'individuazione di un esito, che poteva essere supposto come quello realisticamente più corretto e vero, un numero di voti, e conseguentemente una forza decisionale, comportante un vantaggio politico, maggiore rispetto a quello concesso a quei cittadini meno colti, la cui probabilità di riuscire a formarsi un giudizio simile era da stimarsi, in virtù di questo loro svantaggio intellettuale, come non altrettanto certa.
Finora dunque la concezione epistemica della democrazia sembrerebbe addirittura giustificare, a causa della sua stessa tensione verso il risultato, l'obiezione epistocratica, ma per tentare una comprensione profonda della questione bisognerà introdurre un'importante distinzione: quella cioè fra un tipo di approccio debole (al quale fanno riferimento Estlund e Martì), e uno invece forte (al quale si riferisce Landemore) alla democrazia deliberativa epistemica, poiché le due diverse interpretazioni tentano a loro volta risposte diverse alla controversia2.
In sintesi, le interpretazioni deboli sostengono che il vero valore epistemico sia proprio esclusivamente dell'eventuale deliberazione: è il risultato del processo democratico ad esserne caratterizzato, non il procedimento stesso per mezzo del quale quel medesimo provvedimento è stato raggiunto.
Questo tipo di approccio sembrerebbe però rinunciare, in questo modo, a qualsiasi pretesa confutativa nei confronti dell'obiezione epistocratica: se, infatti, l'obiettivo da raggiungere tramite un processo decisionale dev'essere categoricamente quello dell'individuazione di una risoluzione ad un presunto problema, perché proprio nel risultato del processo deliberativo risiede il valore epistemico, l'interpretazione debole della democrazia non fornisce allora di per sé assolutamente alcuna ragione per la quale si dovrebbe considerare più efficace, nel raggiungimento di questo scopo, e quindi virtualmente più legittima, una procedura democratica rispetto ad una procedura strettamente elitaria che anzi, non c'è ragione di escluderlo, potrebbe tranquillamente rivelarsi come la più efficiente in questo senso.
Per tentare di liberarsi da una simile contraddizione, l'approccio debole è dunque costretto a postulare per la democrazia un valore intrinseco, ossia l'inclusione, accanto ad un esito che possa essere positivo, di una procedura che possa a sua volta considerare tutti gli individui che vi partecipano su un piano di parità .
Al contrario del debole, un tipo di approccio forte alla democrazia non si limita alla contemplazione dei risultati, e sostiene che sia la deliberazione, che il procedimento democratico attraverso il quale la si individua, posseggano entrambi qualità epistemiche.
La prima risposta alla sfida costituita dall'obiezione epistocratica che analizzerò all'interno di questo mio articolo, e che si ricollega, come già accennato, all'approccio debole, è quella elaborata da Estlund, il quale muovendo dal presupposto che solo una procedura che si basi su una eguale considerazione della persona di ogni cittadino possa portare alla formulazione di decreti, che a loro volta possano indurre i membri della comunità a sentirsi obbligati al loro rispetto, elabora un test di accettabilità al quale sottoporre ogni possibile alternativa che riguardi i diversi sistemi di governo adottabili: se anche un solo cittadino, qualsiasi sia il suo QI, qualsiasi sia la sua classe sociale di appartenenza, lo giudicherà come iniquo, questo dovrà essere messo da parte, poiché sarà proprio quel cittadino a ritrovarsi poi soggetto a quelle stesse leggi promulgate dal processo decisionale preso in esame, e dovrà quindi poterle riconoscere come vincolanti, oltre che come le più giuste possibili.
A questo punto sembra opportuno notare come in realtà il valore intrinseco del processo decisionale democratico sia già implicito all'interno del test di accettabilità elaborato da Estlund, benché lui lo neghi.
Come altro potrebbe essere definita infatti una procedura che prevede, per il fine che si prefigge, il consenso di ogni singolo membro della comunità , i cui giudizi verranno tutti considerati su un piano di parità , se non democratica?
E come potrebbe allora un sistema di governo come quello epistocratico, che viola già in partenza il presupposto stesso su cui il test di accettabilità si fonda, sperare di superarlo?
Se quest'osservazione può dunque apparire come un ulteriore limite al tentativo di risposta fornito da Estlund, egli sceglie di negare il controsenso, ed individua comunque delle controbiezioni, che definisce come ragionevoli, da rivolgere al sistema epistocratico, confutazioni dalle quali la democrazia sarebbe al contrario ovviamente immune.
Prima fra tutte si presenta per Estlund la difficoltà d'individuare chi effettivamente siano questi cosiddetti saggi, e l'interrogativo rispetto a quale metodo dovrebbe eventualmente adottare la società per riconoscerli.
A questa prima complicazione poi, ne seguirebbe un'altra, ancora più determinante, perché Estlund presume che se anche la collettività riuscisse ad escogitare una modalità atta al riconoscimento dei cittadini più savi, e a tradurla in una procedura efficiente, sarebbe quanto mai utopistico, per non dire irresponsabile da parte dei cittadini, pretendere di potersi tranquillamente affidare all'operato di questi sapienti opportunamente selezionati, i quali, forse proprio tentati da questa loro tanta decantata sensatezza, sarebbero più inclini alla parzialità che non al suo contrario: il risultato sarebbe insomma quello di una classe politica fortemente settaria, più dedita al perseguimento di un tipo di utilità inerente alla propria classe sociale di riferimento, che non al bene comune.
In definitiva, Estlund ritiene che se anche un limitato gruppo di tecnici potesse essere considerato come il più adatto, come quello avente la più alta possibilità di elaborare le soluzioni migliori in risposta ai vari problemi sociali, rispettando in questo senso l'assunto epistemico, queste loro decisioni si rivelerebbero in realtà inevitabilmente influenzate dall'orizzonte comune che questi potenziali saggi si troverebbero a condividere, e dal quale sarebbero impossibilitati ad astrarsi: come potrebbe, a questo punto, la maggioranza dei governati essere certa che la deliberazione raggiunta dal ristretto cerchio dei governanti sia la migliore possibile in senso assoluto, e non piuttosto la più conforme agli interessi di una certa classe sociale?
Come potrebbe un gruppo di cittadini acconsentire ad un simile sistema, dopo aver riconosciuto la manifesta iniquità delle sue decisioni?
L'alternativa epistocratica fallisce dunque il test di accettabilità .
Tuttavia, quelle stesse insuperabili difficoltà che l'obiezione solleva agli occhi di Estlund, che a causa di tutte le sopracitate ragioni ritiene l'obiezione definitivamente confutata, vengono classificate altrimenti da un altro autore, Martì, il quale le descrive come assolutamente contingenti, prevedibilmente risolvibili.
Si potrebbe pensare, ad esempio, alla semplice elaborazione di un QI test in grado, attraverso i propri parametri, d'individuare le potenzialità intellettive di ciascun cittadino, sarebbe in questo caso possibile, e anzi auspicabile, l'inserimento di alcuni correttivi, che potrebbero essere in grado di identificare fra la cittadinanza le persone più sagge e qualificate a prendere le giuste decisioni per la totalità dei membri della comunità .
Ciononostante, le conseguenze di un simile ragionamento potrebbero spingersi anche oltre, poiché anche supponendo che questi correttivi si rivelassero come non immediatamente applicabili, sarebbe bensì logico supporre che se l'ostacolo costituito dal problema meramente contingente della temporalità fosse superabile, all'interno di una società puramente utopica sarebbe l'epistocrazia, e non il suo contrario, a costituire il sistema di governo più desiderabile.
Questa costruzione, benché immaginaria, possiede comunque l'indubbio merito di chiarire i risvolti reconditi di questo ragionamento: se si arriva a riconoscere che la forma di governo ideale di un'immaginaria, ma esemplare civiltà sarebbe un governo di tipo epistocratico, allora perché non cercare di perfezionare la nostra di società , se non adottando il medesimo modello (dal momento che questo ci sarebbe precluso dalla nostra stessa contingenza), almeno abbandonando quello meno conforme a quest'ultimo, cioè la democrazia?
Martì avverte dunque il bisogno di elaborare una risposta più convincente da offrire all'epistocrate, e la trova nel riservare, all'interno della sfera democratica, un valore intrinseco all'inclusività , e nell'assegnare al processo deliberativo un valore puramente strumentale.
Quella democratica è allora per Martì una forma di governo preferibile rispetto a qualsiasi altra, perché abbraccia ed ingloba al suo interno ogni membro della società , ritenendoli tutti egualmente meritevoli del medesimo grado di considerazione, a prescindere da quali e quanto precise siano le competenze di ciascuno di loro, e perché arriverebbe così, in questo che è l'unico modo possibile, a prendere una decisione che possa veramente essere definita come la migliore immaginabile.
Questa reazione, che vorrebbe essere risolutiva, potrebbe però complicare ulteriormente la questione, perché focalizzando la propria attenzione sul piano dell'inclusivismo, Martì sembra perdere di vista, se non quasi mettere in ombra, quello epistemico: il primo sembrerebbe essere infatti più importante del secondo, e ben misera smentita sembrerebbe giungere, a questo proposito, dal vago sforzo dell'autore di precisarli come comprimari.
Il tentativo di risposta elaborato da Martì sembrerebbe dunque produrre più confusione che chiarezza: le procedure democratiche hanno forse allora il precipuo vincolo d'includere, e solo una volta rispettato questo assunto, se si tratta di procedure deliberative, quello d'individuare la soluzione migliore possibile?
Come si potrebbe a questo punto escludere che la deliberazione, benché segnata dal desiderio d'includere, porti all'individuazione di una decisione che possa rivelarsi decisamente peggiore rispetto a quella che, si può ragionevolmente supporre, un gruppo di tecnici sarebbe stato in grado di formulare?
Questa eventuale soluzione sarebbe allora da considerarsi comunque giusta, equa perché inclusiva, o non sarebbe forse invece da considerarsi ingiusta, incoerente perché non corrispondente a quell'ideale ottimale che sarebbe stato così chiaro nella mente di un'élite istruita?
Di conseguenza, non sembrerebbe in realtà che Martì sia effettivamente riuscito a fornire al potenziale epistocrate alcuna risposta che possa essere considerata definitivamente convincente, se non attraverso un intrinseco svilimento dell'importanza dell'elaborazione di una deliberazione corretta, a tutto vantaggio del valore del processo decisionale, al quale Martì sceglie arbitrariamente di attribuire, per mezzo del suo carattere inclusivo, la vera qualità epistemica.
Entrambi i tentativi fin qui presentati, quello di Estlund e quello di Martì, forniscono evidentemente motivazioni non epistemiche per il rifiuto dell'alternativa epistocratica, com'è proprio di interpretazioni deboli della democrazia deliberativa, ma a valutare attentamente l'obiezione, e a tentare di fornirne una spiegazione che possa invece fruire una reale ragione epistemica per considerare il governo del demos come il migliore, e quindi preferibile a quello dell'élite, è Landemore.
Partendo, ancora una volta, dal presupposto che la priorità di qualsiasi processo decisionale sia quella di giungere alla risposta corretta rispetto al problema preso in esame, e che il prioritario valore epistemico risieda proprio in questa possibile risoluzione (anche se è bene che si ricordi come una prospettiva forte della democrazia deliberativa epistemica riconosca come presenti, all'interno del processo democratico, anche altri valori, oltre a questo del fine risolutivo), Landemore teorizza che non sia la competenza individuale, ma quella collettiva ad avere realmente le maggiori possibilità di poter raggiungere l'obiettivo primario di identificare la soluzione corretta, poiché il risultato ottenuto sarà quello proprio di un processo cognitivo che avrà tenuto conto di opinioni e prospettive varie quanto il numero di coloro che avranno contribuito a formularlo3.
Secondo la definizione di Landemore: «Cognitive diversity is the difference in the way people will approach a problem or a question. It denotes more specifically a diversity of perspectives (the way of representing situations and problems), diversity of interpretations (the way of categorizing or partitioning perspectives), diversity of heuristics (the way of generating solutions to problems), and diversity of predictive models (the way of inferring cause and effect)»4.
Se dunque ci si prefigge l'obiettivo di rispettare l'assunto epistemico del miglior fine, dal punto di vista di Landemore la strada da percorrere è quella di un democratico pluralismo che assicuri al processo decisionale una quantità di differenti cognizioni, piuttosto che quella di un'élite composta dalle personalità più istruite, il cui limite maggiore risiederebbe, in definitiva, nella propria incresciosa incapacità di approdare a soluzioni che possano rivelasi efficacemente creative.
Landemore giudica dunque l'élite irrimediabilmente imprigionata dai suoi stessi schemi mentali, beffardamente acquisiti proprio nel corso di quella formazione intellettuale che avrebbe dovuto renderla invece la più qualificata e la più idonea a governare e che, esercitando la stessa fastidiosa funzione di un'immaginaria benda sugli occhi, la renderebbero incapace di vedere al di là del proprio limitato orizzonte mentale, i cui confini sarebbero delimitati dalle sue preziose, ma in realtà rigide ed atrofizzate nozioni che, in questo senso, arriverebbero a pesare come macigni, macigni che di fatto formerebbero i mattoni con cui sarebbero costruiti quei muri che impedirebbero alle loro menti di scorgere anche la semplice esistenza di possibili soluzioni alternative rispetto a quelle già consolidate.
È indubbiamente questa una stoccata decisiva all'obiezione epistocratica, che Landemore sferra proprio sul piano della formazione intellettuale che inevitabilmente questi saggi, o pretesi tali, condividerebbero, e che li porterebbe ad essere ostaggio tutti dei medesimi pregiudizi, derivanti da una sorta di orizzonte mentale comune che li condannerebbe a commettere continuamente gli stessi errori, impedendogli di approdare ad una qualsiasi forma di evoluzione della situazione presa in esame.
È però necessario chiarire che la forza di questo ragionamento risiede soprattutto nella competenza collettiva propria di un gruppo di persone considerato come tale, e non, come sarebbe invece nelle intenzioni dell'obiezione epistocratica, nell'autorevolezza propria dei singoli membri del gruppo, ognuno considerato come un'individualità a sé stante.
Dunque, anche se è intuitivo riconoscere come le competenze individuali dei singoli membri di un'élite istruita si pongano facilmente su un piano indiscutibilmente elevato, interpretazioni forti della democrazia sostengono che la forza del maggior numero non solo sia in grado di compensare quelle che potrebbero essere delle particolari mancanze soggettive, ma arrivi addirittura a superare la competenza collettiva di un ristretto gruppo di tecnici specializzati.
A questo proposito sembrerebbe opportuno ricordare il tentativo, in forma matematica, che il marchese di Condorcet, alla fine del Settecento, formulò per dimostrare la superiorità delle decisioni prese da grandi numeri di cittadini a maggioranza, a condizione però che la probabilità che ciascun singolo componente del gruppo riesca ad individuare l'alternativa corretta sia superiore al 50%.
Così esposto questo teorema potrebbe offrire di sé un'ingannevole impressione, risultando di supporto a quanto precedentemente detto, ma nasconde in realtà risvolti estremamente indesiderabili che sarà bene specificare.
Prima fra tutte si presenta la difficoltà del livello di competenza medio-alta che una simile teoria presuppone, e del quale non è affatto scontato che tutti i cittadini siano in possesso (anzi, sembrerebbe più verosimile a questo proposito presumere il contrario), il che porterebbe di fatto ad un'illegittima, ma inevitabile all'interno di questa prospettiva, esclusione dal processo democratico di tutti quei membri della comunità la cui capacità intellettuale sia da stimarsi inferiore al livello preventivamente richiesto.
Viene poi l'eccessivo peso, implicitamente accordato da Condorcet, ai possibili cattivi argomenti che, presentati all'interno di un contesto deliberativo, se proposti da abili partecipanti al processo decisionale, potrebbero risultare artificiosamente accattivanti, ed investire con il loro effetto domino l'intero procedimento fino all'estrema conseguenza di una possibile scelta sbagliata.
Ancora una volta si porgerebbe dunque il fianco all'obiezione epistocratica, che potrebbe indubbiamente approfittare di questi incerti sviluppi per presentare a sua volta le regole dell'elitismo come le più adatte al conseguimento del risultato migliore.
L'indubbio vantaggio della tesi elaborata da Landemore è quella di richiedere invece un livello di competenza individuale indubbiamente minore rispetto al teorema elaborato da Condorcet, in vista di una competenza collettiva, che è quella sulla quale basarsi ai fini della decisione, poiché è quella nella quale risiede un livello di capacità e di qualità di problem-solving maggiore rispetto a quello presente nelle individuali capacità dei singoli membri.
Riassumendo, secondo questa teoria maggiore è il numero dei partecipanti alla decisione, maggiore sarà per la democrazia deliberativa epistemica la probabilità di assolvere il compito d'individuare la soluzione migliore possibile: in questo modo Landemore riesce nello stesso tempo a tenerne insieme i due aspetti fondamentali, rispettandone l'assunto epistemico e unendo a questo la necessità di un largo pluralismo tra i partecipanti alla deliberazione.
La risposta di Landemore è a mio parere quella più convincente, poiché sebbene io riconosca come all'interno dei processi decisionali sia indubbiamente necessaria la presenza, fra gli altri partecipanti, di persone che possano vantare la padronanza di solide competenze, a garanzia di una risoluzione che possa essere supportata anche da conoscenze specifiche, il rischio di restringere la cerchia dei governanti ai soli cosiddetti esperti, ossia tra gli altri quello di avere un’agenda politica assolutamente arbitraria, decisa secondo la volontà di un gruppo ristretto, mi sembrerebbe un rischio troppo grande perché ci si possa permettere di sottovalutarlo, e dunque, seguendo una preoccupazione già paventata da Estlund, una delle mie paure a questo proposito si esprime nel timore che un sistema elitario, per quanto meritorio possa essere nelle intenzioni, potrebbe rivelarsi pericolosamente insensibile riguardo ad altri tipi d'interesse, che si ritroverebbero a non essere per nulla rappresentati, e quindi per nulla considerati.
La prospettiva di Landemore è invece, da questo punto di vista, quella che riunisce in sé tutti i punti di vista immaginabili, e quindi tutti gli interessi, anche quelli appartenenti a classi sociali tradizionalmente minoritarie, i cui giudizi potrebbero dissentire rispetto all'opinione della maggioranza, ma che all'interno di questa interpretazione sarebbero comunque garantiti, ed avrebbero una reale possibilità di arrivare ad essere contemplati nel corso del processo decisionale, fino ad offrire un significativo contributo allo stesso, collaborando in questo senso non ad un risultato semplicemente più equo, ma superiore dal punto di vista epistemico.
Bibliografia:
Estlund, D. (1997), “Beyond Fairness and Deliberation: The Epistemic Dimension of Democratic Authorityâ€, in J. Bohman and W. Rehg (eds), Deliberative Democracy, Essay on Reason and Politics (Cambridge, MA: MIT Press), pp. 173-204;
Estlund, D. (2003), “Why Not Epistocracy?â€, in N. Reshotko (ed.), Desire, Identity and Existence: Essays in honor of T. M. Penner (Kelowna, B.C., Academic Printing and Publishing), pp. 53-69;
Martì, J.L. (2006), “The Epistemic Conception of Deliberative Democracy Defended Reasons, Rightness and Equal Political Autonomyâ€, in S. Besson and J.L. Martì (eds), Deliberative Democracy and its Discontents (Ashgate Publishing), pp. 27-56;
Landemore, H. (2013), “First Mechanism of Democratic Reason: Inclusive Deliberationâ€, in Democratic Reason (Princeton: Princeton University Press) pp. 89-117;
Landemore, H. (2013), “Epistemic Failures of Deliberationâ€, in Democratic Reason (Princeton: Princeton University Press) pp.118-144.
1Approccio accostabile a quell'ideale dei filosofi-governanti che già Platone descriveva nella sua Repubblica: «a meno che (…) i filosofi non regnino negli stati o coloro che oggi sono detti re o signori non facciano genuina e valida filosofia, e non riuniscano nella stessa persona la potenza politica e la filosofia (…) non ci può essere (…) una tregua dai mali negli stati e (…) nemmeno per il genere umano».
2Cfr. Martì 2006.
3Teoria, questa di Landemore, estremamente vicina a quella di Aristotele, che nella sua Politica difendeva proprio il carattere di verità delle decisioni prese a maggioranza, anche qualora queste dovessero essere confrontate con quelle prese da minoranze i cui singoli membri risultassero più saggi ed istruiti rispetto ai componenti della maggioranza: «può darsi in effetti che i molti, pur se singolarmente non eccellenti, qualora si raccolgano insieme, siano superiori a loro, non presi singolarmente, ma nella loro totalità (…) In realtà , essendo molti, ciascuno ha una parte di virtù e di saggezza e come quando si raccolgono insieme, in massa, diventano un uomo con molti piedi, con molte mani, con molti sensi, così diventano un uomo con molte eccellenti doti di carattere e d'intelligenza».
4Landemore 2013.
Aggiunto il 01/06/2017 08:26 da Davide Orlandi
Argomento: Filosofia politica
Autore: Davide Orlandi

Lo spazio della politica è compreso all’interno di due orientamenti – che sia Platone che Aristotele descrivono mediante movimenti opposti ma convergenti. E quindi due “impulsi†(c

Come dice Heidegger, l'uomo - invece di poetare l'enigma dell'essere - l'ha ridotto a un rapporto di forze. Rischiando così di perdere definitivamente se stesso.

Egregio Dott. Luca Mercalli, Le scrivo questa lettera per esprimere alcune suggestioni che la Sua relazione, dal titolo “La crisi ecologica vista dalla scienzaâ€, tenuta presso il Palazzo