- Accedi
- Registrati

Da Schopenhauer a Freud
48,75 €
Dalla Grecia antica ad Agostino
22,40 €
Dal moderno al contemporaneo
20,80 €
La filosofia moderna e contemporanea: dal Romanticismo all'Esistenzialismo
29,92 €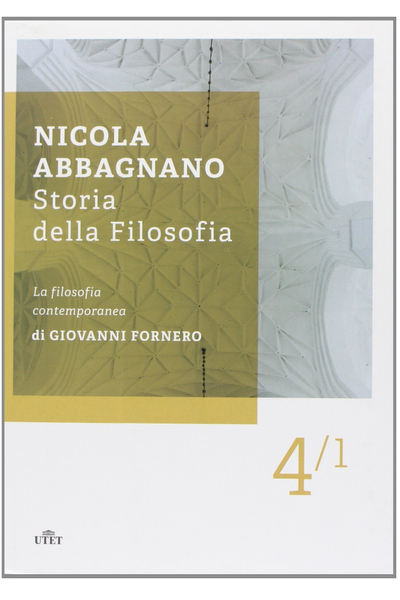
La filosofia contemporanea
30,40 €
Medioevo e rinascimento
22,40 €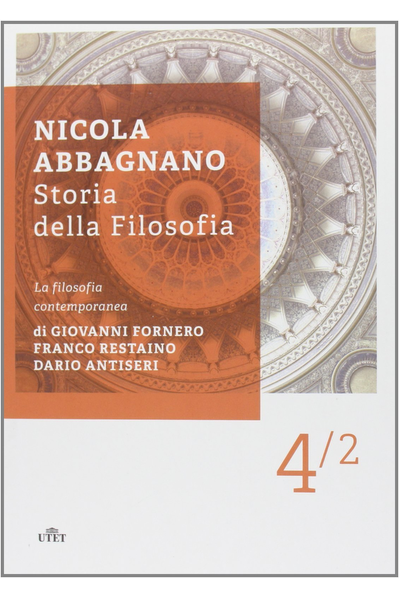
La filosofia contemporanea
30,40 €
Dalle origini ad Aristotele
39,70 €
Dalla crisi della modernità agli sviluppi più recenti
13,50 €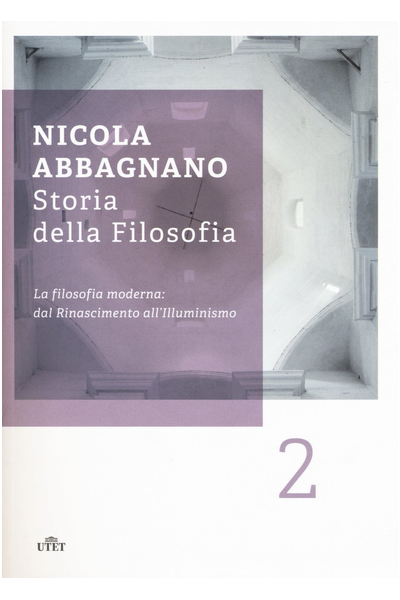
La filosofia moderna: dal Rinascimento all'Illuminismo
27,07 €Deleuze proponeva «un Hegel filosoficamente barbuto, un Marx filosoficamente glabro così come si pensa a una Gioconda baffuta»[1]; ecco come la filosofia postmoderrna, per paura di “tornar pericolosa”, abusa dell’ironia. Ma Lei non ha paura, col suo Manifesto, d’aver tagliato i baffi a Nietzsche (o al suo sosia Umberto I)? d’aver decostruito il decostruzionismo con le sue stesse armi?
Non ne ho affatto paura. Anzi, in tutta franchezza me lo auguro. Altrimenti per quale motivo mi sarei occupato di decostruzione e di Nietzsche per così tanti anni? Solo per fare il verso a Nietzsche e alla decostruzione? Sarebbe stato dilapidare il mio tempo, e mi auguro di non essere così stupido. D’altra parte, non voglio nemmeno rientrare nel novero dei fedeli imitatori, dei seguaci, degli zeloti o dei pasdaran, di quelli che Deleuze chiamava “tristi ripetitori”, il mondo ne è pieno e si accalorano su chi è “il vero erede” di questo o di quello. Mi sembra una posizione gregaria e niente affatto desiderabile.
Questo tuttavia non significa che io non abbia fatto il possibile per imparare da grandi maestri, e in particolare da Derrida e dalla sua>
E il secondo obiettivo deve consistere nel ricostruirla su altre basi. Provo a spiegarmi meglio. Hilary Putnam, che personalmente ha una grande stima di Derrida, ha scritto che ogni decostruzione senza ricostruzione è irresponsabile. In questo convergendo pienamente con Derrida, che era solito ripetere che ogni decostruzione comporta una ricostruzione. Il che in un senso è ovvio. Pensi alle montagnole che, a Milano o a Lipsia, sono state costruite con le macerie delle case bombardate. Ma ovviamente sarebbe auspicabile che la ricostruzione fosse qualcosa di più sistematico e organizzato del fabbricare montagnole con le macerie. Ed è proprio su questo punto che l’esigenza di radicalismo intrinseca alla decostruzione viene a intrecciarsi con l’istanza di realismo immanente alla ricostruzione.
C’è dunque un senso in cui non sono mai stato così vicino a Derrida come quando ho cercato di ricostruire la decostruzione, e ho proposto una ontologia realista. Perché, come diceva Ermolao Barbaro in una disputa cinquecentesca sull’imitazione, bisogna assomigliare ai maestri come il figlio al padre, non come la scimmia all’uomo.
“Etica della responsabilità”, della coscienza d’un impegno critico comune, potrebbe essere perifrasi o presupposto di “realismo” – della sua pars costruens, della sua funzione positiva –, per come lo intende Lei?
Sì, e non è molto, direi che il minimo sindacale per un’etica è che comporti un riferimento alla responsabilità e alla realtà. Eppure, per paradossale che ciò possa apparire, c’è stato e c’è chi dice che l’etica della responsabilità è poca cosa, che chiunque sarebbe capace di attuare un’etica simile, e che la vera etica consiste nell’irresponsabilità, o (che è lo stesso) nella responsabilità anche nei confronti di ciò di cui non siamo responsabili. Ma queste ovviamente sono futilità scritte per impressionare i più semplici. Se uno si dichiara responsabile di tutto, anche del fatto che il sole tramonti (come in effetti fa quel burlone di Zarathustra, quando dice “si è fatta sera, perdonatemi se si è fatta sera”), si fa carico di una responsabilità così iperbolica che viene a coincidere con l’irresponsabilità. A mio modo di vedere, invece, ci sono almeno due sensi in cui la realtà ha un nettissimo profilo etico.
Il primo è, banalmente, il fatto che senza realtà non ci può essere moralità, ma semplicemente intenzioni, buone o cattive, ma indistinguibili dalle immaginazioni. Un santo o un genocida in sogno non sono né un santo né un genocida. E questo è il motivo per cui tutti gli “addii alla verità”, gli “indebolimenti della realtà”, gli scetticismi, gli accanimenti ermeneutici hanno immancabilmente come risultato il fatto di diminuire la responsabilità, e dunque l’impegno etico. Spesso gli stessi decostruttori ed ermeneutici e debolisti se lo dimenticano, ma quella posizione che oggi presentano come iper-etica, come un fardello doloroso, la presentavano trent’anni fa come una gioiosa macchina da guerra, come il superamento del peso della responsabilità, dell’etica e della tradizione, come l’apertura di un nuovo modo desiderante e rivoluzionario.
C’è poi un secondo senso, meno storico e decisamente più filosofico. Contrariamente a quello che spesso si sostiene (e che hanno sostenuto anche grandi filosofi come Hume) può essere del tutto lecito dedurre il dover essere, cioè l’etica, dall’essere, cioè l’ontologia. Se io vedo una persona che sta annegando mi sembra che da questo essere derivi un dover essere, o sbaglio? Tanto è vero che l’unico modo efficace per impedirmi di sentire (di sentire almeno) questo dovere consiste nel dirmi che la persona non sta annegando davvero, ma si tratta di una ripresa cinematografica, di una mia allucinazione, o di qualcosa di simile. Questo carattere vincolante mi viene non solo dall’ontologia, ma anche dall’epistemologia. Poniamo che io sia un medico, e che sappia che dando al malato un certo farmaco ne provocherei la morte. Qui l’ontologia (la composizione del farmaco) e l’epistemologia (che io conosca la composizione del farmaco e i suoi effetti) determinano l’etica, il dover-essere segue strettamente dall’essere.
La rivolta contro il realismo delle nostre società di massa può essere risultato di quel processo di atomizzazione distruttore delle antiche certezze comunitarie? Cioè a dire, è possibile che l’insoddisfazione dell’uomo moderno, quanto mai individuo e destinato alla solitudine, possa abbandonarsi all’immaginazione edificatrice di realtà personali, a propria misura, verso il primato dell’interpretazione?
Non credo. Personalmente ritengo il processo di individualizzazione un processo magari doloroso ma doveroso, un momento di emancipazione dell’umanità, non ho alcuna nostalgia per le antiche certezze comunitarie tra cui si annoverano – non dimentichiamolo – la xenofobia, i roghi delle streghe, le croci del ku klux klan e le svastiche delle SS. E poi, quanto all’interpretazione, c’è un punto che non vorrei venisse equivocato. Io non sono affatto contrario all’interpretazione. Quello che rimprovero al postmoderno è di avere fatto un uso regressivo dell’interpretazione, mai davvero praticata (non mi sembra che i postmoderni interpretino più di altri) ma semplicemente adoperata per diffondere uno scetticismo un po’ ribellistico, come dire “la terra gira intorno al sole” “questa affermazione potrebbe essere interpretata”. Che senso ha? È interpretare? No, è semplicemente voler avere l’ultima parola a basso costo.
La crisi (κρίσις, scelta) chiama il cambiamento. Le nostre pretese d’eternità fanno attrito col divenire, l’unico vero orizzonte di senso – per questo la storia è la storia delle crisi. Oggi la crisi è di sistema, così dicono i filosofi. È un fatto, poiché la crescente difficoltà di comprare casa non offre troppi spunti all’interpretazione.
La svolta realistica, che ricorda all’uomo la sua qualità di faber, come può competere con una mentalità che ha disimparato a pensare il futuro: “il sistema non può essere cambiato, godiamoci il presente (anche se gramo)”?
Non sono sicuro che il realismo insista sull’homo faber. Casomai, era l’antirealismo che trasformava ogni professore in un demiurgo, intento a costruire la realtà attraverso le sue interpretazioni (nella maggior parte dei casi immaginarie, come abbiamo appena visto). Il minimo che si possa dire del realismo, a proposito di cambiamenti, è che i cambiamenti devono essere reali e non puramente immaginari. Per restare in tema di decostruzioni e macerie, sto leggendo in questi giorni i Diari di Galeazzo Ciano, ed è interessante confrontare le fantasie belliciste del 1937 con il triste confronto con la realtà del 1942, quando è ormai chiaro a tutti che la guerra è persa. Bene, spesso l’antirealismo si considera rivoluzionario perché sembra dirci che tutto è possibile, basta volerlo, come nelle fantasie del 1937, e spesso il realismo sembra iettatorio o rassegnato perché viene a torto paragonato allo stato d’animo del 1942. Non c’è ragionamento più sbagliato. Il vero punto è che se si fosse stati realisti nel 1937 ci saremmo evitate le catastrofi (oltre che le pagliacciate, le fughe e le viltà) del 1942 e anni successivi. Insomma, la pretesa rivoluzionarietà dell’antirealismo non è molto diversa dal servilismo dei generali che assicuravano Mussolini dello spirito guerriero dell’esercito, della qualità delle attrezzature militari, della efficacia dell’organizzazione, e dalla stolta visionarietà di Mussolini che gli dava retta e che aveva confuso l’Italia con la Prussia.
Lei afferma, per assurdo, che per uscire dalla crisi economica – costruzione sociale – sarebbe sufficiente cancellare le registrazioni dei nostri atti e produrre un’amnesia universale; mentre niente potrebbe arrestare un uragano – elemento naturale indipendente. La società della “mobilitazione totale” come potrebbe, secondo Lei, allentare l’ansia di performatività imposta dall’ubiquità delle comunicazioni?
Premetto in primo luogo che l’amnesia universale è un rimedio alla crisi economica che non mi sento affatto di consigliare, trattandosi appunto di un “rimedio eroico”, che comporta la morte del malato insieme alla malattia. E premetto in secondo luogo che “l’ansia di performatività” non è dovuta alla tecnica, ma alla volontà di potenza di molti esseri umani (me compreso, ovviamente), che vogliono strafare e rispondere alle aspettative della società. Insomma, non sono tanto incline a pensare che la colpa sia sempre della tecnica e della società. È spesso colpa degli individui. Per esempio, non c’è nessuno che mi obblighi a risponderle il 26 dicembre, come sto facendo adesso, e se ho deciso di farlo devo prendermela soltanto con me stesso. Probabilmente, però, se lo faccio è anche perché in qualche modo, magari un po’ perverso, mi diverte, così come probabilmente si divertono tutti quelli che stanno a scrivere tutto il santo giorno. Nulla di così grave, dunque, il grave incomincia quando si è costretti, senza nessun piacere, a rispondere alle esigenze della mobilitazione totale, e questa purtroppo è una condizione umana molto più diffusa della mia.
Lei ha risposto alla mia mail di domenica pomeriggio: sapere non voleva dire emanciparsi? Ma allora qual è il rapporto tra consapevolezza ed emancipazione? Non si rischia di diventare la salma più consapevole del cimitero?
Vuol dire che ero uno schiavo al computer, dunque non ero emancipato? In un certo senso sì, ma c’è di buono che la mia schiavitù è liberamente scelta, poiché nulla mi obbligava a rispondere, tranne il gusto per la filosofia, il piacere un po’ perverso di cui le dicevo un momento fa, e il rispetto nei confronti di una persona che mi aveva scritto. Ma, torno a dirlo, per altri, purtroppo, non c’è così tanta libertà, ed è a quegli altri che bisogna pensare.
Fonte: Rickdeckard
Aggiunto il 28/01/2013 14:08 da Admin
Argomento: Filosofia contemporanea
Autore: Stefano Scrima

Etica e politica in Aristotele Ogni azione, compiuta in base ad una scelta, mira ad un fine, che è un bene, qualcosa che si r

Primogenito di una famiglia della borghesia intellettuale salernitana, termina gli studi classici a 17 anni ed inizia a frequentare la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università d

Quella sensazione che abbiamo quando ce ne stiamo senza far niente e ogni tanto, guardando l’orologio, ci diciamo: “accidenti, oggi sembra proprio che il tempo non passi mai!” non è affatt