- Accedi
- Registrati
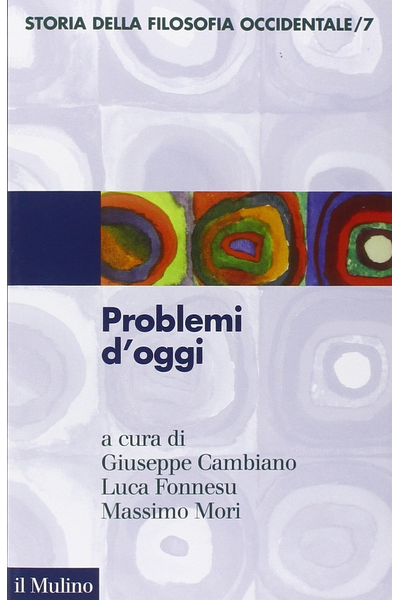
Problemi d'oggi
18,40 €
Dalla Grecia antica ad Agostino
22,40 €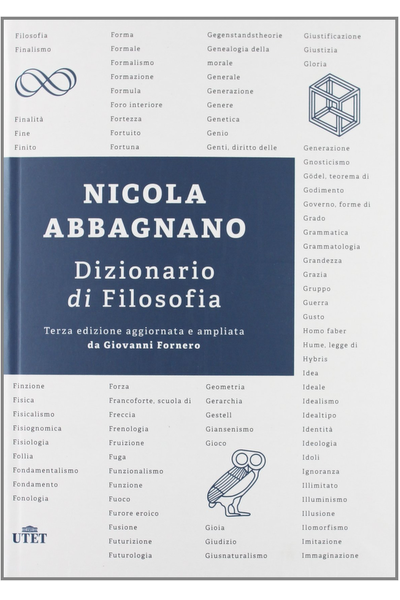
Terza edizione aggiornata e ampliata da Giovanni Fornero
35,00 €
Medioevo e rinascimento
22,40 €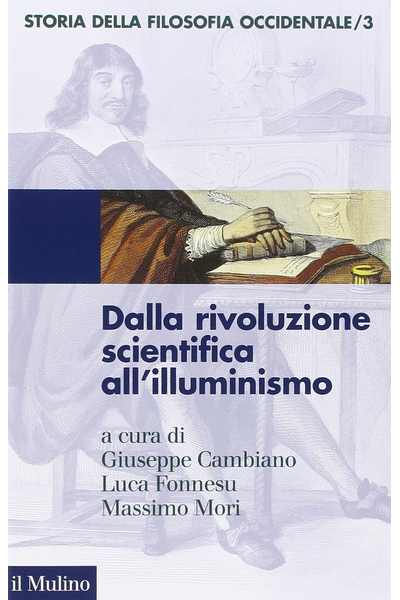
Dalla rivoluzione scientifica all'illuminismo
21,60 €
Dalle origini ad Aristotele
46,55 €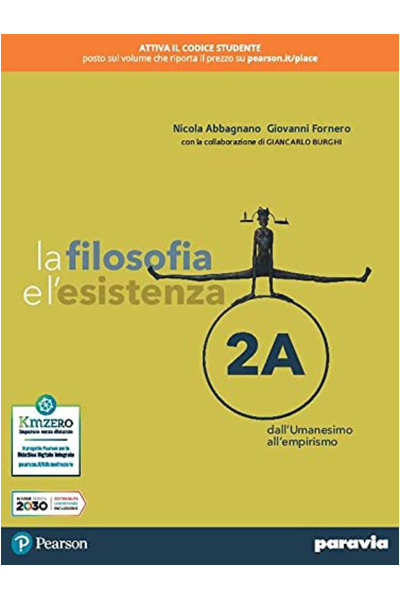
Dall'Umanesimo all'empirismo
51,90 €
Convivere con lo straniero
23,66 €
Dalla crisi della modernità agli sviluppi più recenti
13,50 €
Da Schopenhauer a Freud
52,50 €La concezione dello spazio in Leibniz e Newton
di Giovanni Mazzallo
Lo spazio fa parte dell’insieme
di concetti primitivi (come il tempo, la causa, il principio) che sono stati
sempre ben presenti nella mente dei più grandi pensatori di ogni epoca storica,
i quali non hanno mai mancato di avvalersi delle maggiori ipotesi filosofiche
per sostenere la propria tesi (o criticando l’ipotesi precedente o
interpretandola in una versione completamente nuova ed originale) fino a
usufruire, come accaduto in età post-rinascimentale nel pieno della Rivoluzione
scientifica iniziata da personalità quali Copernico, Brahe e Keplero (e
finalmente condotta da Galilei che pose fine una volta per tutte
all’eliocentrismo aristotelico-tolemaico fino ad allora imperante in ambito
filosofico-scientifico), delle nozioni più avanzate raggiunte in ambito
sperimentale. Ciononostante, i filosofi scienziati del XVII e XVIII secolo, pur
consci del fervido periodo di splendore culturale in cui si venivano a trovare
storicamente, non scissero mai dalle considerazioni analitiche di carattere
scientifico una speculazione approfonditiva di stampo più prettamente
filosofico. Questo non soltanto perché l’influenza della Chiesa (protestante e
cattolica) era assai vasta al tempo, ma anche, soprattutto, per il fatto che
l’uomo, che solo da poco era uscito dall’epoca medievale teologica
caratterizzata da una visione nettamente teocentrica tesa a ridimensionare le
aspettative, le finalità e le capacità cognitive umane sulla base dello sfondo
aureo della divinità ineffabile che a tutto soprassedeva, e la ricerca delle cui
proprietà essenziali era l’unico compito che si richiedeva alla filosofia in
ambito scolastico, per andarsi a ritagliare un proprio spazio di riflessione
che lo reintroduceva nella dimensione che maggiormente gli spettava ed era a
lui consona, ossia la natura (si pensi allo storico Ernst Bloch che nel suo Filosofia del Rinascimento tratta delle
conseguenze storiche derivanti dalla differente concezione
estetico-antropologica fra l’arte bizantina ricollegantesi all’universo
teocentrico medievale e l’arte rinascimentale che riannetteva l’uomo alla
natura riconferendogli quella dignità d’essere e quella capacità e brama di
sapere quasi odissiaca che lo avrebbe indotto a scoprire i veri e propri
confini, le colonne d’Ercole, del suo sapere, come accaduto posteriormente con
Kant), non era ancora del tutto depurato dalle “scorie” del pensiero esercitato
nei secoli precedenti; il che recava con sé l’effetto di indurre l’uomo ad
appellarsi all’onniscienza e all’onnipotenza divina ogniqualvolta, nelle sue
meditazioni scientifiche o filosofiche, si imbattesse in concetti misteriosi
non ancora meglio definiti che non si pensava di saper meglio spiegare se non
in considerazione di quanto all’uomo restava ancora sconosciuto ed
impenetrabile al proprio intelletto. In tal senso, Cartesio, maggiore esponente
del razionalismo scientifico di quest’epoca, adottò in merito al mondo una
visione di carattere essenzialmente meccanicista per rendere conto in maniera
quanto più oggettiva ed assoluta possibile dell’ordine naturale della realtà
pur di mostrare come questo fosse in uno stato di intima connessione con le
facoltà epistemiche dell’essere umano in quanto res extensa comunicante ed interagente a livello gnoseologico con
la res cogitans rappresentata
dall’intelletto umano. Così facendo, Cartesio credette di aver formulato a
pieno diritto le denotazioni gnoseologiche ed ontologiche fondamentali del
rapporto mente-mondo, così come della relazione anima-corpo, ma in ogni caso,
al fine di tutelare il sistema filosofico da lui improntato in base al suo
metodo scientifico di analisi (scomposizione) e sintesi (unificazione) dei dati
empirici provenienti dalle constatazioni effettuate sui fenomeni naturali per
assicurare l’ottenimento di una conoscenza quanto più pura possibile, dovette
ricorrere all’idea suprema di Dio come garante ultimo e infallibile delle
conoscenze umane, che pertanto, in ultima analisi, ricevevano la loro
attestazione di validità da istanze giustificatrici di carattere metafisico
atte ad assicurare l’approdo a forme di sapere in cui il dubbio (non nella sua
veste positiva ed edificante di dubbio metodico, ma nella sua forma negativa e
distruttiva di dubbio iperbolico) veniva finalmente superato poiché era Dio
stesso, da cui tutti gli esseri erano originati, a garantire in senso puramente
ontologico che, data l’origine delle creature a partire da esso, la loro
conoscenza non poteva che essere assolutamente certa sulla base della
veridicità dei fatti localmente osservati ed analizzati attraverso il metodo
scientifico instaurato da Cartesio. Spinoza cercò di conciliare il piano divino
e quello naturalistico stendendo un progetto speculativo in cui era ammesso un
solo ordine necessario valente per tutte le cose, ossia un ordine di carattere
squisitamente geometrico in cui era possibile rilevare la precisa esattezza
necessaria di ogni singola forma della realtà che riproduceva il piano stesso
prefigurato da Dio in maniera univoca per il dipanarsi fenomenologico del reame
naturale del creato nella sua sostanzializzazione in diversi modi e in
differenti attributi. Per Spinoza, che si collocò sulla scia del razionalismo
di matrice cartesiana, non vi era scissione vera e propria in questo senso fra
la natura e la mente; anzi, era del tutto legittimo ricercare l’unione fondamentale
di res cogitans e res extensa nell’unico ordine geometrico
necessario sottostante all’esplicarsi della natura empirica stabilito
unilateralmente da Dio, che è la Natura stessa. Naturalmente tale concezione
non poteva che addossare una certa dose
di “panteismo” alla visione spinoziana della realtà (cosa per cui egli stesso è
stato criticato a più riprese dai suoi coevi, oltre che dai successivi studiosi
di filosofia), ma questo non ha importanza nel considerare che ancora una volta
la scienza, al suo iniziale sbocciare in Occidente come reale scienza
sperimentale, non era ancora assolutamente indipendente da considerazioni di
tipo filosofico-metafisico. Dio, in altri termini, era ancora ben presente
nella mente degli scienziati, tanto quanto nelle menti dei filosofi, se non di
più. Il discrimine, in effetti, fra queste due figure non è ancora ben
delineato e si può rilevare un esempio di compresenza di filosofia metafisica e
scienza in uno di quei giganti del pensiero passati alla storia sotto la definizione
di “genio universale”, Leibniz. La sua intera attività di pensiero è percorsa
dal pensiero dominante che l’ordine della natura, a differenza di quanto
sostenuto da Spinoza, non è di tipo geometrico, quindi non è per nulla
necessario; tutt’al più, nella visione leibniziana esiste un ordine frutto di
una scelta assolutamente libera, la scelta di Dio, il quale sceglie del tutto
liberamente, in accordo unicamente a motivi deontologici nei confronti degli
esseri (quindi dell’uomo), il migliore dei mondi possibili. Ciò sta a
significare che in Leibniz nella considerazione di tipo scientifico della
costituzione del reale la geometria, posta a capo di ogni cosa da Spinoza come
via di accesso a Dio stesso che si identifica nelle forme multiformi della
natura, così come la matematica, attraverso cui Cartesio sostiene che la mente
intensiva può conoscere il mondo estensivo (a tal scopo egli determina
l’utilizzo empirico-materiale dei riferimenti geometrici col suo celeberrimo
sistema di coordinate del piano), possiede importanza epistemica del tutto
secondaria, dato che originariamente all’ordine della natura non è ancora
impressa alcuna forma sensibile predeterminata (pertanto necessaria). Lo
spazio, in tal senso, è da intendersi per Leibniz come a-prioristicamente
indeterminato,non formato, quindi, in definitiva, inesistente. Si può dunque
ben dire che la visione leibniziana del concetto di spazio sia allora ben
differente da quello dato in seguito da Kant come forma a-priori della
sensibilità che produce le intuizioni da cui dipende la formulazione dei
giudizi sintetici a-priori. Lo spazio non ha una sua consistenza, non è per
nulla identificabile con un punto o a livello puramente mentale, è un concetto
trascendentale che non è possibile nemmeno formulare. Per Leibniz, l’idea di
spazio, e la sua formulabilità intellettuale, è concepibile soltanto nel
momento in cui compaiano corpi che, per via della loro stessa costituzione
materiale, non possono che presentarsi manifestativamente se non localizzati,
quindi posti in un dato luogo (il concetto di luogo implica necessariamente
quello di spazio), così che solo allora diviene possibile parlare
effettivamente di uno spazio reale e non ideale, del tutto inesistente e
inconcepibile. Come soleva affermare, nihil
est in intellectu, quod non fuerit in sensu, excipe: nisi ipse intellectus.
La conoscenza non può quindi che passare attraverso il vaglio dei sensi da cui si
origina il fondamento stesso della possibilità del conoscere. Senza i sensi,
l’uomo non può che lasciarsi trascinare dalle proprie fantasie ed
elucubrazioni, che trovano nell’ideazione immaginaria dello spazio ideale (cioè
privo di corpi che lo determinino nella sua conformazione topologica) il loro
limite massimo di esprimibilità. D’altro canto, con tale massima Leibniz
intendeva affermare anche l’effettiva potenza dell’intelletto umano
indipendente dall’ausilio necessario dei sensi . Alcuni credono anche che
questa frase anticipi per molti versi l’intelletto kantiano come “centro
mentale unificatore” delle impressioni sensibili, ma appare più corretto
affermare che, piuttosto che prefigurare ante
litteram una sorta di trascendentalità delle possibilità conoscitive umane,
Leibniz, con tale frase, abbia voluto chiarire più espressamente che
l’intelletto è logicamente dato nell’essere umano a prescindere dai sensi, di
modo che il pensiero, in quanto tale, non si può ridurre unicamente ai sensi in
quanto questi, benché siano imprescindibili nell’acquisizione delle conoscenze,
non pregiudicano le facoltà intellettive proprie della mente umana che, laddove
i sensi non possono arrivare (come nel caso della comprensione della genesi dei
concetti fondamentali della realtà, come lo spazio), può esercitare liberamente
il suo pensiero esprimendosi nei caratteri della logica. A tal proposito,
Leibniz intendeva conciliare meccanicismo e finalismo, materialismo e
spiritualismo, scienza e metafisica, nella costituzione di un potente apparato
logico denominato characteristica
universalis (o “arte combinatoria”) capace di rintracciare l’ordine
fondamentale non solo del sapere, ma anche delle dinamiche stesse del pensiero
umano applicantesi ai problemi di vario
genere afferenti ai diversi ambiti dello scibile, così da ridurre più
praticamente la questione della conoscibilità della realtà utopisticamente a
una mera questione di calcolo nei termini di una scrittura ideografica
universale. In tal modo, Leibniz prelude alla possibilità di intravedere la
mano di Dio nell’ordine delle cose in base ai dettami della logica che, pur
esprimendo verità di ragione basantesi sui canonici principi logici
aristotelici, nel momento in cui si estende all’ordine empirico della realtà
non può che prevedere una consequenziale estensione dei principi logici alle verità
di fatto perennemente cangianti
basantesi sul principio di ragion sufficiente (ciò che accade, accade senza
necessità), cui i principi logici stessi vanno pertanto opportunamente
adeguati. È nell’inclusione del principio di ragion sufficiente proprio delle
empiriche verità di fatto all’interno dell’arte combinatoria fondata
essenzialmente sulle logiche verità di ragione che Leibniz credeva si potesse
rendere conto del carattere modale essenzialmente non-necessario della realtà,
in quanto tutto ciò che sussiste si trova in tale stato non per necessità
a-prioristica, ma fondamentalmente per un atto di scelta divina che Dio ha
effettuato in conformità alla sua natura perfetta. In tale visione, Leibniz si
distacca quindi anche da Cartesio nel non separare marcatamente il piano
filosofico-metafisico da quello scientifico. Quest’atto di scelta è stato teso
alla realizzazione del miglior mondo possibile fra tutti quanti in absoluto. Questa verità può essere
compresa fra le verità di ragione che includono infinite possibilità, ma tale
caratteristica delle verità di ragione necessita di essere regolata dalle
verità di fatto attestanti come però non vi sia che un solo mondo, e che tale
mondo, in base alle possibilità delle verità di ragione, altro non sia che il
miglior mondo possibile scelto fra tutte le possibilità possibili. In tal senso
l’arte combinatoria, conciliando verità di ragione e di fatto, può permettere
di comprendere la natura profonda dell’universo. Il principio di ragion
sufficiente implica quindi una causa finale (la scelta del miglior mondo
possibile), non ammessa né da Cartesio né da Spinoza. L’unica necessità che si
instaura nell’universo voluto e scelto da Dio è rappresentata dalla stretta
dipendenza della sussistenza dello spazio dai corpi che lo vengono a
configurare. Lo spazio per Leibniz, come il tempo, non esiste né assolutamente
né a-prioristicamente, in quanto la postulazione della sua esistenza è
collegata inscindibilmente alla presenza dei corpi da cui dipende il
concepimento intellettuale e fisico del concetto di spazio stesso. Lo spazio e
il tempo, pertanto, sono in questo senso relativi (relativi ai corpi
naturalmente, non in senso einsteiniano), in quanto enti (o concetti)
dipendenti dalle relazioni che i corpi intrattengono fra loro e che l’uomo è
capace di esprimere mentalmente attraverso lo spazio e il tempo. Lo spazio
esprime i rapporti di coesistenza fra le cose, mentre il tempo stabilisce
l’ordine di successione temporale delle cose. In quanto fenomeni apparenti e
soggettivi che si relazionano all’intelletto percepente dell’essere umano, lo
spazio e il tempo rientrano fra le maniere umane di rappresentarsi l’unico
ordine oggettivo ed assoluto ammesso da Leibniz, ossia quello dell’armonia
prestabilita fra le monadi che costituiscono gli elementi basici della realtà
universale. Poiché per Leibniz la materia risulta essere determinata dalla
forza come elemento originario del mondo fisico (che sostituisce l’estensione e
il movimento cartesiani), e la forza rappresenta quindi la vis viva, lo spirito animante la natura e i suoi esseri, allora,
con l’apprestamento del sistema monadologico della realtà, Leibniz concretizza
anche in ambito fisico (dopo aver introdotto nell’ambito della logica formale
la characteristica universalis) l’unione
di materia e spirito, metafisica e scienza, ammettendo la forza come principio
metafisico che fonda le leggi stesse della fisica, fondato su una concezione
continua della natura che non fa mai salti, ossia non è divisibile in
costituenti atomici indivisibili cui si arresta la materia nel suo substrato ma
è caratterizzata da diversi gradi intermedi che garantiscono l’infinità stessa
della materia, quindi della natura che, in quanto animata dallo spirito, dalla vis viva costituita dalla forza, si identifica
in Leibniz con lo spirito stesso (non più direttamente con Dio, come per
Spinoza), indi con le differenti monadi che altro non sono se non sostanze
spirituali che rappresentano i costituenti irriducibili fondamentali della
realtà. L’armonia prestabilita da Dio delle monadi fa sì che la realtà sia
omogenea e coerente nel suo progressivo manifestarsi e determina altresì la
perfetta sincronia ontologica fra la monade-corpo e la monade-anima che, pur
seguendo apparentemente leggi ontologiche diverse, si ritrovano unite in un
accordo predisposto sin dall’eternità da Dio che assume le sembianze
dell’entelechia aristotelica estendentesi anche alla fisica leibniziana (corpo
come forza passiva che riceve le influenze dell’esterno ed esteriorizza a sua volta la predisposizione
dell’anima come forza viva, quindi spirito, che anima l’essere dal suo interno
e determina il suo conformarsi in relazione sia alla sua costituzione
ontologica innata sia alle influenze materiali esterne apportate sul corpo,
cosicché anima e corpo sono in uno stato di perenne e reciproca comunicazione).
Lo spazio infine, per Leibniz, non è assoluto, è relativo ai corpi che lo
determinano. Una visione del tutto antitetica della faccenda venne data da
Newton. Newton, che con Leibniz intrattenne una famosa disputa in merito alla
paternità del calcolo infinitesimale (effettivamente, si può dire che l’unico
punto che i due pensatori avevano in comune fosse la reciproca convinzione nella
natura infinitamente continuativa della realtà), è passato alla storia per la
sua celeberrima legge della gravitazione universale che aveva posto termine
alle discussioni avutesi in tale ambito di ricerca nei tempi precedenti
(Copernico aveva riconosciuto la forza di gravità come forza che attrae i corpi
celesti fra loro, Huygens aveva dato la formula della forza centrifuga, Borelli
quella della forza centripeta). I corpi celesti, egli teorizzò e dimostrò, si
attraggono proporzionalmente al prodotto delle masse e inversamente al quadrato
delle distanze. Ciò che Newton non riusciva pienamente a spiegarsi era
l’origine della velocità iniziale di cui i pianeti erano provvisti nella loro
descrizione di un’orbita ellittica attorno al sole data dalla spiegazione
puramente meccanica della composizione dell’inerzia del pianeta e della forza
attrattiva esercitata su di esso dal sole. Da dove derivava, dunque, tale
velocità iniziale? Per Newton la risposta non poté che trovarsi in un atto
creativo della divinità, che avrebbe impresso ai corpi celesti un impulso
iniziale che avrebbe originato il loro incremento di moto fino a raggiungere
l’attuale velocità ritenuta, per l’appunto, iniziale in quanto non meglio
specificata se non alla luce di considerazioni di tipo teologico-metafisico. È
quindi chiaro, in Newton, che il solo fatto che Dio abbia impresso un moto ad
ogni singolo pianeta, che godono di un moto proprio attorno al sole datogli
direttamente da Dio, sta ad indicare come la concezione del moto, che egli
aveva, fosse di carattere esclusivamente assolutistico. Essendo il moto per
Newton assoluto, anche lo spazio (quindi il tempo) in cui veniva a prodursi
tale moto doveva essere assoluto. Lo spazio, in Newton, era una specie di
contenitore oggettivistico assoluto che racchiudeva tutti i corpi, il cui
ordine di successione degli eventi si stagliava in un tempo oggettivo ed
assoluto eternamente fluente, e risultava essere il sensorium Dei attraverso cui Dio era perennemente compresente
all’ordine delle cose nel creato, nella natura, così che Newton, trasponendo la
metafisica teologica cartesiana in ambito meccanicistico piuttosto che in puro
ambito gnoseologico, concilia nella sua visione di insieme meccanicismo e
metafisica ponendo sempre al centro di tale disegno l’azione ineluttabile di
Dio e lasciando al contempo un certo grado di arbitrarietà comportamentale alla
materia, limitata in tal senso nelle sue forme di manifestazione esclusivamente
dalle leggi di natura dominanti (i tre principi newtoniani della dinamica
classica) che la regolano ed aiutano a comprenderla (contrariamente al
carattere necessitario dell’ordine geometrico della natura postulato da
Spinoza). Tale concezione urtava con forza contro la visione di Leibniz, che
non concepiva nulla di assoluto nella maniera di concepire l’ordine oggettivo e
naturale della realtà, semmai di relativo, relativo ai corpi, quindi agli
avvenimenti, ai fenomeni, agli eventi naturali, che non implicano l’esistenza
già data di uno spazio assoluto, ma anzi implicano questa stessa solo
successivamente non perché ne siano sostanzialmente la causa ontologica, ma
perché ad esserne la causa gnoseologica sono nella fattispecie le loro
relazioni che necessariamente (e solo qui si può appurare un carattere di
necessità all’interno della costruzione leibniziana), essendo localizzate,
giacché prefiguranti un luogo non possono che inerire anche a una concezione
dello spazio. Il principio di ragion sufficiente (non necessaria) concede che tutto
ciò che già c’è basta per non doversi chiedere perché non avrebbe potuto essere
altrimenti, dato che è il frutto di una scelta ben precisa compiuta da Dio che
ha preferito, in virtù della sua onniscienza ed infinità bontà e perfezione,
una situazione universale piuttosto che un’altra (come attestato dalle verità
di fatto e previsto dalle verità di ragione), e questa situazione universale,
formulata in base al principio di ragion sufficiente per cui l’unico fatto che
importa è rappresentato dalle relazioni ontologiche delle cose che
incidentalmente danno adito al formarsi delle idee di spazio e tempo nelle
monadi per via del loro modo di concepire e rappresentarsi oggettivamente i
fenomeni (spazio e tempo sorgerebbero quindi come “accidenti” dell’esserci
delle cose), non ha perciò necessità, in Leibniz, di uno spazio assoluto perché
è superfluo ai fini della creazione divina già perfetta (e non perfettibile,
visto che Dio è la suprema monade perfetta) e lo spazio, in quanto tale,
“nasce”, come il tempo, solo in relazione ai corpi (quindi lo spazio è
relativo). Essendo lo spazio relativo, in Leibniz il moto non può che essere
relativo. Se in Newton, effettuando una rotazione o una traslazione universale,
si determinano modifiche sostanziali nella distribuzione della materia nello
spazio (concezione puramente metrica dello spazio), in Leibniz, invece,
effettuando una qualsivoglia traslazione, non si effettuerà alcun cambiamento
perché la priorità realitaria è data dall’ontologicità delle relazioni fra i
corpi (concezione topologica dello spazio). Newton, per provare che il moto,
assoluto, avviene sullo sfondo di uno spazio assoluto, ideò l’esperimento
mentale del secchio pieno d’acqua facendo notare che, fatto compiere qualche
giro al secchio legato ad un’asta che lo fa roteare, dopo che l’acqua si è
mossa in seguito al moto trasmessole dal secchio cui si è impresso il moto a
partire dall’asta, è possibile vedere che anche quando il secchio ha smesso di
roteare l’acqua continua a muoversi inclinandosi leggermente in alto. In tal
modo, l’acqua si muoverebbe in maniera assoluta rispetto non più al secchio, ma
allo spazio assoluto. Leibniz, da parte sua, riprendendo l’armonia prestabilita
fra le monadi, obiettò che due corpi, due monadi, si possono dire differenti
fra loro solo quando sono diversi per proprie qualità interne. Nel caso dello
spazio assoluto indifferenziato, se si considera un corpo che si muove nello
spazio anche con moto accelerato, tale accelerazione non sarà mai pienamente
percepibile dato che lo spazio assoluto non offre punti di riferimento
apparenti per determinare la qualità del moto del corpo considerato, che, anzi,
potrebbe anche sembrare che non si differenzi per nulla in questo senso dallo
spazio “assoluto” su cui avviene il suo moto che, non differenziando in
apparenza il corpo dallo spazio, potrebbe anche non star avvenendo affatto.
Questo perché il moto si può definire appieno solo in relazione ad un altro
corpo, rispetto al quale è più probabile e logico affermare in quale stato si
trovi un corpo che rispetto allo spazio assoluto indifferenziato. È questa
un’applicazione del celebre principio leibniziano degli indiscernibili. Se il
moto quindi è relativo, anche lo spazio non potrà che esserlo, dal momento che
esso si dà solo in base alla relazione fra i corpi e anche qualora i corpi si
considerino come stagliantisi su uno spazio assoluto non compreso dalle loro
relazioni, ma comprendente gli oggetti stessi, allora sarebbe impossibile
distinguere i corpi in sé dallo spazio assoluto. Tale diatriba non si sarebbe
risolta fino all’arrivo di Einstein, che, rivedendo alla luce della sua teoria
della relatività la “relativita” di spazio e moto ammessa da Leibniz, e
confutando l’assolutismo newtoniano accettato dogmaticamente da Kant, avrebbe
formulato l’esistenza del cronotopo, ossia dell’entità tetradimensionale
costituente l’universo fisico provvisto di una sua geometria unificante i
concetti di spazio e tempo in base ad esperimenti mentali e fisici comprovanti
come il moto sia assoluto unicamente rispetto alla propria regione
spazio-temporale e, in conclusione, lo spazio e il tempo siano fisicamente (non
solo intellettualmente alla maniera leibniziana) relativi (non assoluti alla
maniera newtoniana).
AFFILIAZIONI
Scuola Superiore di Catania (studio compiuto nel merito delle ricerche che sto compiendo al fine della stesura della mia tesi per il diploma di licenza magistrale della Scuola sulla filosofia dello spazio-tempo di Hans Reichenbach)
Aggiunto il 15/10/2015 10:44 da Giovanni Mazzallo
Argomento: Storia della Filosofia
Autore: Giovanni Mazzallo

Riflessioni pascaliane su Pale Blue Dot Era il 1994 quando alla Cornell University l’astrofisico Carl Sagan presentava agli studenti dell’aten

EPIGRAFE: " Il gran dolore è un raggio divino e terribile che trasfigura gli infelici" (Victor Hugo, "I Miserabili")PREMESSAE' arduo parlare di Dio Ogni pensier

Le utopie letterarie teorizzano società ideali considerando l'individuo non per ciò che è, ma come dovrebbe essere. Per giustificare le stesse teorie e fare in modo c