- Accedi
- Registrati
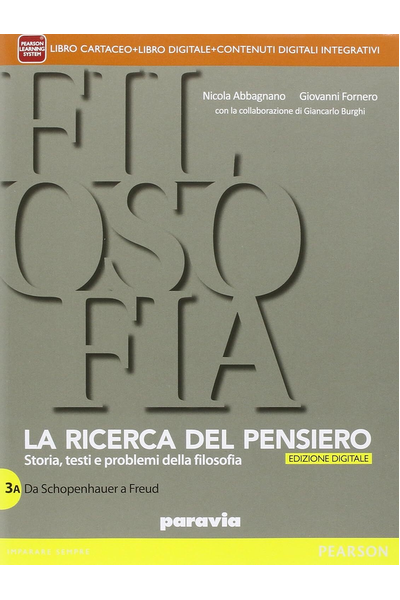
Da Schopenhauer a Freud
52,50 €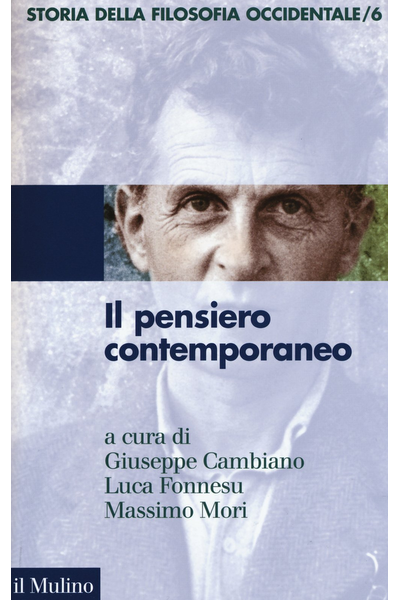
Il pensiero contemporaneo
22,40 €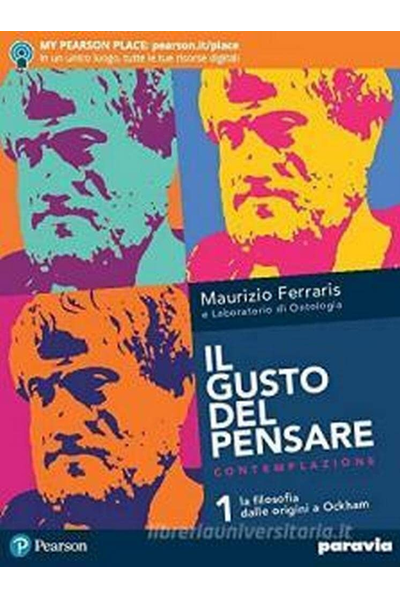
La filosofia dalle origini a Ockham
31,20 €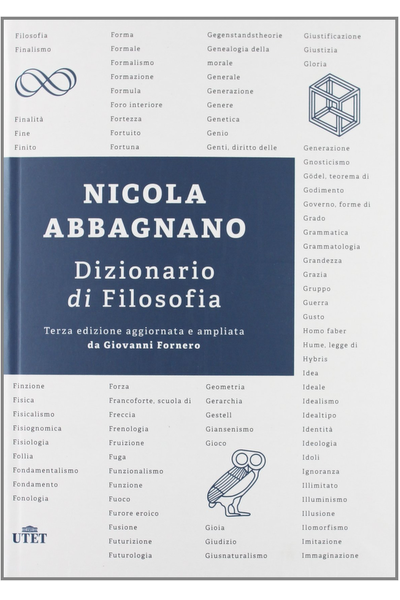
Terza edizione aggiornata e ampliata da Giovanni Fornero
35,00 €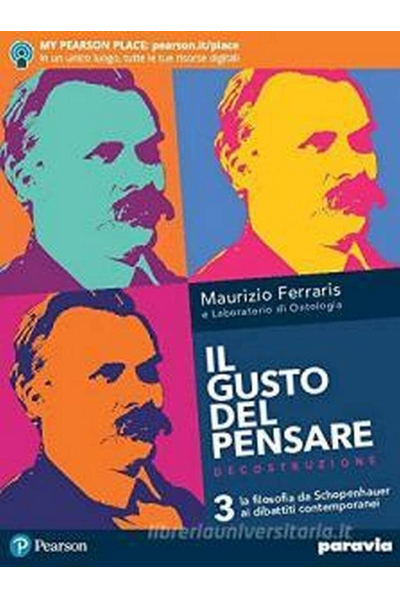
La filosofia da Schopnhauer ai dibattiti contemporanei
40,10 €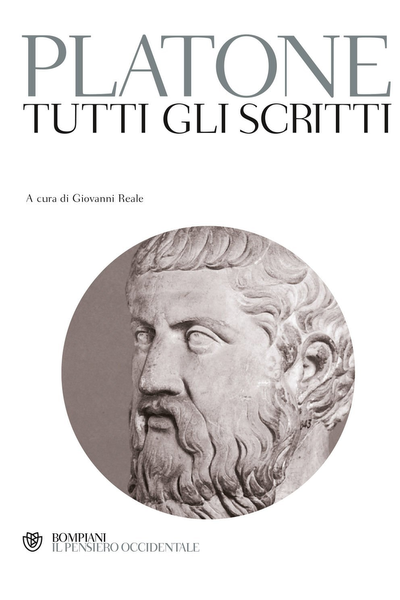
Tutti gli scritti
60,00 €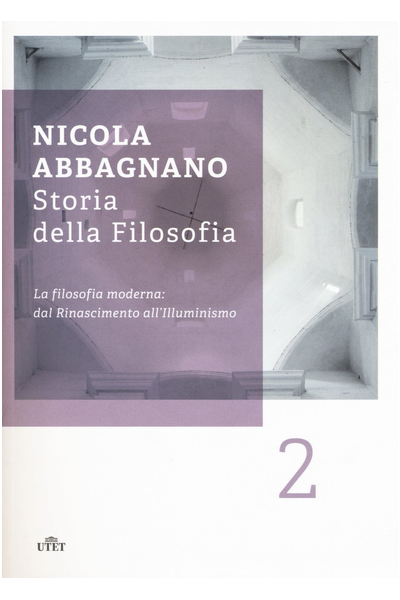
La filosofia moderna: dal Rinascimento all'Illuminismo
27,07 €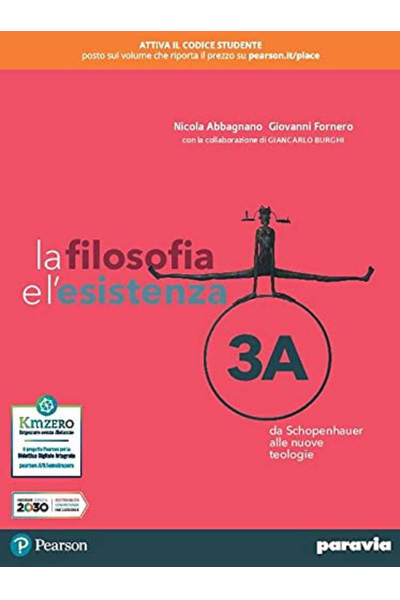
Da Schopenhauer alle nuove teologie
51,60 €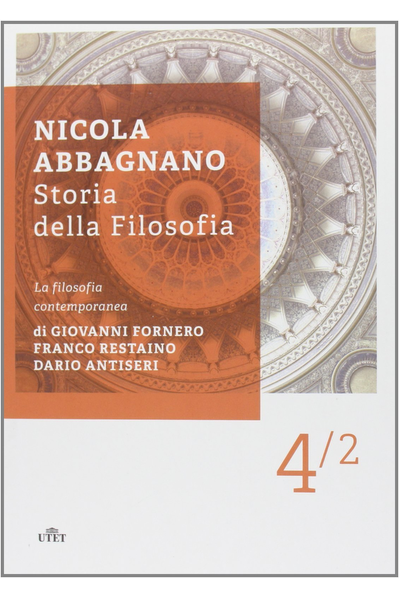
La filosofia contemporanea
30,40 €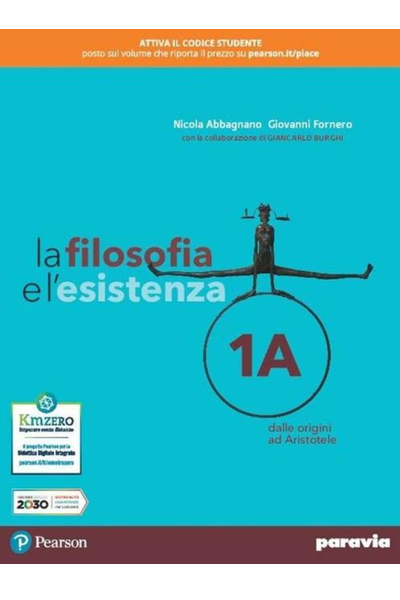
Dalle origini ad Aristotele
39,70 €ARISTOTELE
ETICA NICOMACHEA
II.
di Davide Orlandi
Aristotele sottolinea che gli argomenti trattati nell’etica non sono adatti né ai giovani (che non hanno esperienza delle azioni concretamente vissute) né, più in generale, a chi vive assecondando le passioni e lasciandosi da esse trascinare (perché per essi la conoscenza teorica di questi argomenti risulta inutile).
Aristotele si concentra a questo punto sulla concezione platonica del bene, che viene criticata in modo molto dettagliato. Dopo aver ricordato l’amicizia che lo lega ai platonici (Amicus Plato, sed magis amica veritas), Aristotele dichiara però che un filosofo deve onorare più la verità dell’amicizia e che quindi per quanto sgradevole questo possa sembrare prenderà in esame le teorie di Platone. Tutte le critiche possono essere ricondotte a due grandi temi: innanzitutto Aristotele mostra come sia impossibile avere una concezione unitaria del bene, afferma che non esiste un bene in sé, che i molteplici significati di “bene” non possono essere ricondotti a un’unità, come invece pretendeva Platone (è una critica che riprende su un piano etico quella teorica contenuta nella Metafisica, dove Aristotele sostiene che l’«essere si dice in molti modi», non in uno solo); in secondo luogo egli sottolinea che, se anche questo presunto Bene in sé esistesse, l’uomo non potrebbe realizzarlo e quindi esso sarebbe, per il nostro discorso, sostanzialmente inutile. Noi dobbiamo infatti partire da ciò che è primo per noi, non da ciò che è primo in assoluto. Aristotele prende in considerazione la possibilità di partire dal Bene in sé e utilizzarlo come modello (παράδειγμα) per poi conoscere il bene per noi, ma risponde chiaramente che nessuna conoscenza procede in questo modo e che non si capisce quale giovamento potrebbe portare nel concreto l’aver contemplato l’idea in sé. Il bene non è mai, per Aristotele, un semplice modello imitabile, ma una realtà che si trova, in misura diversa, nelle nostre azioni.
Riprendendo il discorso sulla felicità, Aristotele la definisce come “un che di perfetto e autosufficiente” cioè qualcosa che ricerchiamo in sé e non in vista di altro: è qualcosa di stabile che dà a sua volta stabilità e autosufficienza, intesa come capacità di trovare in sé la propria soddisfazione. Per quanto importante essa sia, non è la sorte a determinare la felicità. Essenziale per la felicità è vivere secondo virtù, perché è attraverso di essa che la si può raggiungere. La sorte è accessoria, sebbene importante (cfr. 1100b 4-12). Inoltre, la felicità è legata alla funzione specifica dell’uomo, al suo fine più proprio (perché è della felicità e del bene dell’uomo di cui si discute). La funzione specifica dell’uomo, ciò che lo caratterizza, è la parte razionale dell’anima (la parte non razionale è comune anche agli animali). Inoltre la felicità è sempre un’attività, un’ενέργεια. Qui si vede come l’etica aristotelica sia guidata da un’antropologia precisa, ovvero da una precisa concezione di ciò che è l’uomo: è un animale dotato di ragione, la quale guida la sua finalità. La felicità dunque può essere raggiunta esercitando la finalità più propria dell’uomo, la ragione, per agire secondo virtù. Aristotele conclude infatti dicendo che «il bene dell’uomo consiste in un’attività dell’anima secondo virtù». E aggiunge: «in una vita compiuta» un solo giorno o una sola azione non rendono nessuno felice o virtuoso (“una rondine non fa primavera”). La virtù, infatti, non è riducibile a un atto, ma è piuttosto un’attitudine, che implica un sapere e un saper fare, ma che non si identifica con essi. Per essere tale, la virtù dev’essere un fare abituale, appreso mediante l’esercizio.
Il sommo bene è quindi sempre un’attività, mai un possesso: è l’esercizio della virtù che implica piacere. Chi agisce secondo virtù non ricerca un piacere ulteriore, estrinseco, perché le sue azioni sono per lui fonte di piacere.
Aristotele dice chiaramente che la virtù non è accessibile a tutti: questo ci ricorda i limiti del modello aristotelico, che rimane un modello classico, aristocratico, legato alle virtù della parte migliore della popolazione, ben distinta dalla massa. Più in generale i barbari, gli schiavi, le donne, non possono davvero raggiungere la virtù e la conoscenza nella loro forma più elevata. Si tratta però di un limite culturale della grecità antica, e non di un’impostazione strettamente aristotelica. Sotto questo aspetto, Aristotele si è limitato ad accogliere l’ethos del suo tempo e a sistematizzarlo, senza entrare in collisione con esso.
Nella concezione aristotelica, si noti, la virtù non è fine a se stessa, ma è quell’attività in cui il pensiero e l’azione sono all’altezza di ciò che mi rende uomo. Non la perseguo per sé, ma per la felicità, ovvero per ciò che mi consente di accedere alla mia umanità, per estrinsecare le mie più alte possibilità di uomo.
Aggiunto il 08/09/2018 01:38 da Davide Orlandi
Argomento: Filosofia antica
Autore: Davide Orlandi

So che vorrei solo la libertà, non voglio più il guinzaglio, gli abbracci soffocanti e soprattutto niente bagni umilianti, in fondo non cerco neanche un granché; un mondo senza recinti come

Come dice Heidegger, l'uomo - invece di poetare l'enigma dell'essere - l'ha ridotto a un rapporto di forze. Rischiando così di perdere definitivamente se stesso.

ARISTOTELE ETICA NICOMACHEA VI.di Davide Orlandi Nel libro VI Aristotele affronta le virtù