- Accedi
- Registrati

Dal moderno al contemporaneo
24,70 €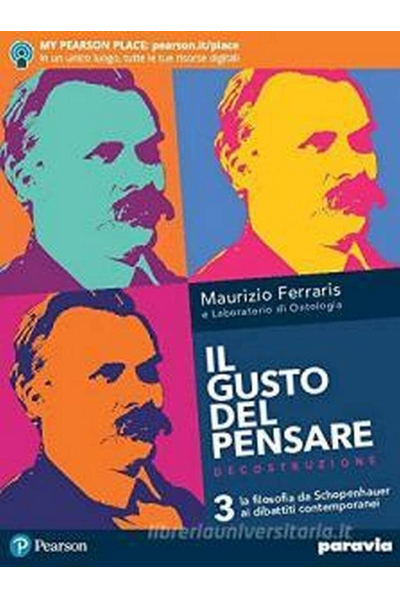
La filosofia da Schopnhauer ai dibattiti contemporanei
40,10 €
Dalle origini ad Aristotele
35,70 €
Dalle origini ad Aristotele
39,70 €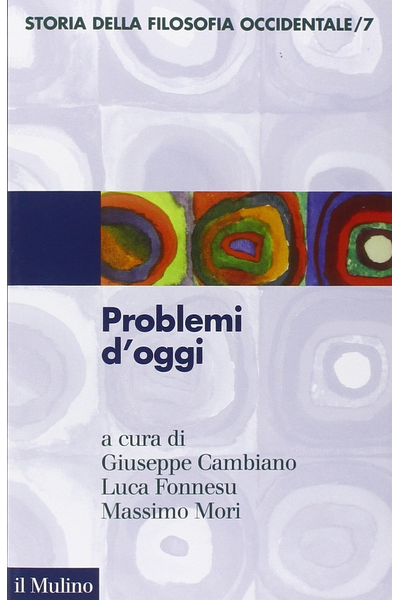
Problemi d'oggi
21,85 €
Saggio per un'interpretazione filosofica
15,90 €
Romanzo su una indifferibile rinascita dell'umano
6,24 €
La filosofia dalle origini a Ockham
31,20 €
Medioevo e rinascimento
26,60 €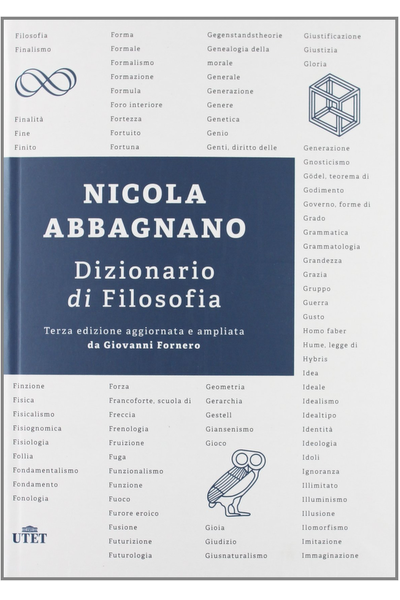
Terza edizione aggiornata e ampliata da Giovanni Fornero
33,25 €
Così ci invita a riflettere Albert Camus: «Se l’uomo riconoscesse che anche l’universo può amare e soffrire, si riconcilierebbe con questo. Se il pensiero scoprisse nei mutevoli specchi dei fenomeni, eterne relazioni che potessero sintetizzarli e sintetizzarsi esse stesse in un unico principio, si potrebbe parlare di una felicità dello spirito, di cui il mito dei beati sarebbe soltanto una ridicola contraffazione. Questa nostalgia di unità, questa brama di assoluto spiega lo svolgimento del dramma umano nella sua essenza».¹
Mi accingo ad argomentare intorno a questa “brama di assoluto” attraverso questi quattro punti:
- A partire da Kant e lo speculativo pensare per tracce
- Oceano e deserto… tracce di Assoluto
- Intelligere est pati: antecedenza e vincolatività dell’infinito sul finito
- Luce dell’Essere e vivere nell’Assoluto
1 . A partire da Kant e lo speculativo pensare per tracce
Scrive Immanuel Kant: «Dal momento che, per la possibilità di tutte le cose, la ragione deve presupporre come data la realtà, e considera la diversità delle cose attraverso le negazioni che ineriscono loro solo come limiti, essa si vede costretta a porre a fondamento come unica possibilità originaria quella dell’essere illimitato, considerando quindi derivate tutte le altre. E dal momento che anche la possibilità in generale di ogni cosa va ricercata nella totalità dell’esistenza, o quantomeno è solo così che il principio della determinazione in generale mette la nostra ragione nelle condizioni di distinguere il possibile dal reale, troviamo che la necessità di porre a fondamento di ogni possibilità l’esistenza di un essere massimamente reale (sommo) ha una ragione soggettiva, è cioè un bisogno della nostra stessa ragione».²
Ciò che è qualcosa, non può che esserlo nella totalità del suo essere qualcosa; e questa (totalità) si pone, sia che il qualcosa coincida con il tutto, sia che il tutto comprenda il qualcosa e il suo altro; in ogni caso, il qualcosa che è chiama in causa quella totalità che rappresenta, quantomeno, “il principio di determinazione della nostra stessa ragione”.
Anche nel pensiero della “totalità” si rende, dunque, necessaria l’esigenza di pensare all’Assoluto o, con le parole di Kant, all’ “essere massimamente reale (sommo)”: un bisogno della ragione da intendersi come salvaguardia di una trascendentalità irriducibile alla conoscenza oggettiva di una qualsiasi cosa.
Perciò, la ragione esige l’Assoluto come principio incondizionato, ma ben presto si rende anche conto che una tale ragione implica un’intenzionalità ed un’apertura (allo stesso Assoluto) tali da non poter essere pensati solo in termini razionalistici, soggettivistici od oggettivistici che siano.
Ecco, allora, perché, a mio avviso, si deve piuttosto pensare a/parlare di “tracce di Assoluto”, dove il termine “traccia” ha il compito di liberarci dai limiti di un’indicazione esclusivamente empirico-scientifica, dovendo riferirsi, invece, ad una realtà che non può essere solo quella relativa ad un positivismo oggettivo, sensibile, fattuale.
Tanto il senso (che esprime la concretezza e l’immediatezza sensibile di una prassi vitale) quanto il significato (che indica invece una più comunicabile oggettività concettuale e inter-soggettiva) che costituiscono e sostanziano la parola “traccia” esprimono, dunque, un’intenzionalità che non resta legata e delimitata ad un referente reperibile nella modalità di un’esperienza e/o certezza che sia solo logica, o solo sensibile, o solo scientifica.
“Scire est agere, intelligere est pati”³: questa sentenza di Aristotele può aiutarci a capire meglio l’intenzionalità della traccia rispetto all’intenzionalità conoscitiva che si esplica sul piano di un’oggettività empirico-sensibile; mentre quest’ultima (intenzionalità conoscitiva) dà luogo ad un sapere che è anche un agire (scire est agere), l’intenzionalità della traccia deve venir intesa come quell’intuire/comprendere che è, piuttosto, un subire/patire (intelligere est pati) il darsi/imporsi delle tracce di Assoluto appunto.
Qui, nell’intelligere, l’intenzionalità pensante del soggetto umano viene a trovarsi nella condizione di una passività (il pati dell’intelligere, appunto) a causa dell’irrevocabile assolutezza rivelata dal darsi/imporsi delle tracce di Assoluto, che per ciò stesso vengono a significare/rappresentare quel “solido terreno” in/su cui ogni pensare/conoscere umano può iniziare, alimentarsi e procedere. Per questo, si deve parlare di “traccia” per dire l’intenzione di significare-simbolizzare che è intima al nostro pensare, un pensare che, per questo, non è nemmeno ‘libero’ di pensare ciò che vuole.
Con parole prese in prestito da Massimo Cacciari, posso allora dire che “traccia” «[…] rimanda ad un rapporto del pensiero con l’essente più originario, pre-potente, rispetto a quello che nel lógos diviene consapevole problema e aperta interrogazione… [traccia che] non può esaurire in sé la possibilità del pensare, tantomeno lo può la sua forma logico-razionale».⁴
Non posso, quindi, che condividere pienamente la seguente perspicace conclusione dello stesso Cacciari: «‘Illusione linguistica’ è credere che le strutture della lingua ‘esauriscano’ il pensiero, o ne rappresentino l’inconcusso fondamento, tanto quanto ‘illusione teoreticistica’ credere che il pensiero possa giungere a dotarsi di un proprio lógos in grado, esso soltanto, di predicare l’essenza dell’ente».⁵
Dunque, si deve opporre una chiara e decisa critica tanto a chi ritiene di trovare risposta e soluzione alla filosofica interrogazione dell’essere nella conoscenza dell’uso delle parole e delle loro regole grammaticali, considerandole per di più come indiscutibile fondamento, quanto a chi ritiene che il pensiero possa enucleare e/o costruire una ‘logica’ in grado di dimostrare o mostrare in esclusiva il senso dell’essere (idealismo metafisico).
Penso che il senso e il significato di “traccia” possa evitare entrambi le illusioni evidenziate da Cacciari, e questo spero si potrà cogliere anche nel prosieguo di questa mia riflessione.
Al momento, posso dire che la “traccia”, pur radicata nel pati dell’intelligere dell’intuizione dell’essere, può mostrare la sua attività (non solo passività dunque) nel pensare simbolico-anagogico che esprime lo sforzo di salire più in alto o di scendere più in profondità, un sempre teso dinamismo della mente che, ad esempio, il sintagma anselmiano “id quo maius cogitari non potest”⁶ esprime con insuperabile incisività.
Infatti, come sottolinea Paul Gilbert, «il pensiero del “maius” non è in nessun modo il pensiero di una “cosa” che sarebbe inclusa nei confini della cogitatio rappresentativa e argomentativa. Kant osservava che i “confini” sono anche delle “frontiere”, che hanno quindi un significato perché vi sarà un successivo territorio, un al di là. […] Il sapere della frontiera e di ciò che sta al di là è anche un sapere valido, benché sia altro dal sapere di un sistema chiuso all’interno delle frontiere e nelle loro determinazioni».⁷
Quanto alle solite obiezioni degli anti-metafisici o, ancor meglio, degli anti-speculativi per i quali, come sottolinea Rocco Ronchi, «ogni pretesa all’assoluto è instancabilmente liquidata come ingenuità e superstizione»⁸ e che vorrebbero perciò mantenere il pensiero rigorosamente delimitato, per non dire imprigionato, dentro a confini empirico-sensibili, mi piace riportare queste acute e incisive riflessioni di Ernst Bloch: «Dobbiamo rifiutare ogni trasformazione riduttiva dei nostri pensieri. Dobbiamo mantenere la fame senza ingannarla: essa sa soltanto di non essere saziata né dall’una né dall’altra cosa, e può unicamente presentire ciò che infine la sazierà e non c’è ancora. Chiedersi come ci si rappresenti la beatitudine è tanto poco proibito da essere, in fondo, l’unica domanda permessa. … [nell’agire altrimenti] si finirebbe per essere come degli acquirenti che, pur desiderando qualcosa di assolutamente diverso, sono costretti ad accontentarsi delle merci disponibili, dimenticando proprio il primo, indeciso desiderio».⁹
2 . Oceano e deserto… tracce di Assoluto
Con un’intensità poetico-speculativa tale che anche le parole riescono a malapena ad esprimere, così ci sollecita Friedrich Hölderlin: «Un fuoco divino ci trascina, di notte e di giorno, ad aprirci la via. Su vieni, guardiamo nello spazio aperto, cerchiamo ciò che è nostro, per quanto lontano».¹⁰
Ma l’Assoluto, cui il pensiero è nostalgicamente richiamato, viene da Kant immaginato (ecco l’esprimersi del pensare simbolico-anagogico) come un “ampio e tempestoso oceano”¹¹ che circonda l’isola della verità dove, solamente, sono le vie praticabili dell’umana ragione: è un richiamo nostalgico, tanto desiderato quanto interdetto dai rigorosi limiti del conoscibile.
Ma, per l’immediato stupore (thaumaston) che sorge di fronte all’esistenza di una cosa qualsiasi¹², stupore derivante dall’incapacità di dedurre quel puro e semplice esistere, anche l’immagine del deserto può tornare utile qui ad indicare l’Assoluto, il deserto di un pensare che non riesce a conoscere razionalmente neanche l’esistenza di un qualsiasi esistente e, allora, qui non c’è neppure un’isola da delimitare rispetto ad un oceano tempestoso.
Con l’assoluto oceano riesco a figurarmi un’illimitata vastità, nella quale cerco di ritagliare una parte conoscitiva, ma con l’assoluto deserto del “puro esistere” mi accorgo dell’impossibilità di comprendere, totalmente e compiutamente, anche quella pur parziale conoscenza e, allora, prendo atto che conoscere vuol dire dover mettere nel conto dovuto un’insuperabile astrattezza, soprattutto quella che nasce dalla separazione tra soggetto conoscente ed oggetto conosciuto, come avviene nel caso della conoscenza empirico-scientifica.
Eppure, anche le immagini di ‘oceano ‘ e ‘deserto’ non sembrano totalmente vuote o insensate; anzi, esprimendo un modo di pensare simbolico-anagogico, rivelano un uso sensato e un’indubbia possibilità di significare e di intenzionare ciò che supera e che va al di là dei confini di un pensiero meramente rappresentativo e dimostrativo.
Infatti, il loro approccio figurativo (simbolico-anagogico) è quello, come afferma Emmanuel Lévinas riferendosi all’idea dell’Infinito, di «un pensiero che in ogni momento pensa più di quanto non pensi».¹³
Questo “di più” o “sovrappiù” che il pensiero “riesce a pensare” è proprio quel maius (sopradetto) che in ogni pensare simbolico-anagogico pur eccedendo e restando al di là, viene “toccato” in questa dinamica tensione, una tensione anche per significare che lo stesso Assoluto resta tale, cioè Absolutum: participio sostantivato di ab-solvo, che significa “sciolto”, “libero da” qualsivoglia legame o limite, come quello, ad esempio, di un pensare che lo vorrebbe circoscrivere e/o possedere. L’Assoluto ha in sé un infinito “poter essere” e, perciò, non può sottostare al alcuna “necessità di essere” che non dipenda dal suo stesso essere, e, dunque, dalla sua libertà; questa libertà dell’Assoluto tiene insieme e senza contraddizione, “necessità” e “possibilità”: includendo pienamente in sé quest’ultima (possibilità) e non essendo condizionato dalla prima (necessità), l’Assoluto dispone sovranamente tanto della possibilità quanto della necessità.
È questa eccedenza di pensiero che impedisce di restare entro i confini del semplice rappresentabile e razionalmente dimostrabile, un’eccedenza che, tuttavia, non pregiudica la sensatezza e la significatività di un pensare che cerca di farsene un’idea/immagine come quelle di oceano e deserto; l’incapacità di queste immagini ad esaurire e a comprendere le tracce di Assoluto non si traduce peraltro in una totale negatività o proibizione a pensare all’Assoluto, come se, per dirlo poeticamente con Gabriele d’Annunzio fossero “labbra che un divieto chiuda”.¹⁴
Come non riesco a comprendere l’illimitata vastità di un assoluto oceano, così, e ancor più, non riesco a cogliere l’illimitata profondità di “Ciò” che mi appare come l’abissalità di un assoluto deserto.
È come se l’Assoluto mi si rivelasse con la volontà di attutire, con sublime ironia, lo stupore, l’impatto (thaumaston) del suo darsi e imporsi, sdoppiandosi in quella dualità di forme o immagini quali quelle che ho appena indicato con ‘oceano’ e ‘deserto’, ma che ora si possono indicare, più speculativamente, come tracce e, dunque, come tracce di Assoluto.
Tracce che riesco ad intuire – nella forma del “pati dell’intelligere” – nel modo seguente: non sono il tutto, eppure, in un certo modo, al tutto penso – e me lo figuro come un oceano –, anche solo per dire che non lo sono (ma forse posso solo immaginarmi come una goccia d’acqua di quell’oceano): penso e vivo la tensione agonica per questa infinita estensività; non sono l’origine di me stesso, eppure, in un certo modo, penso all’origine – e me la figuro come un deserto a causa di una totale assenza concettuale –, anche solo per dire che non la (l’origine) sono (più difficile qui immaginare che cosa posso essere rispetto a questo deserto assoluto dell’origine): penso e vivo la tensione agonica per questa infinita intensità.
Dunque, è il pensiero dell’infinito che mi si rivela, mostrando i limiti, spaziali e temporali, della mia finita esistenza; peraltro, come potrei divenir consapevole di quest’ultima se quel pensiero dell’infinito non mi si rivelasse pur nella sua enigmatica evidenza?
Insomma, «se l’uomo riconosce la finitezza, allora vuol dire che non è totalmente immerso in essa. […] non è più l’uomo che cerca di inglobare la verità; al contrario, l’uomo si abbandona alla verità, per esserne inglobato. Noi, dunque, non siamo mai “fuori” dalla verità, ma sempre radicati in essa, che lo sappiamo o meno. […] La verità cercata, cioè l’assoluto, cioè Dio inteso nella sua essenza concettuale, non è semplicemente immanente alla coscienza, poiché non è un suo contenuto, né è semplicemente trascendente, poiché la coscienza è illuminata dall’assoluto stesso e solo in virtù dell’assoluto può riconoscere il relativo, compresa la propria relatività, compresa la propria finitezza».¹⁵
3 . Intelligere est pati: antecedenza e vincolatività dell’infinito sul finito
Non posso che affidarmi all’intuizione di queste tracce di Assoluto, e le penso, come un intuire che, come scrive Ronchi, mi «desta dal sonno antropologico […] (e mi) indirizza verso quel Grande Fuori, che è il territorio vergine da sempre promesso a una filosofia che si voglia veramente speculativa».¹⁶ Ecco come e perché intuisco un’infinita intensità anche solo nel fatto che qualcosa è, così come intuisco un’infinita estensività comprensiva nel pensiero di tutto ciò che è, perché è proprio come afferma Pierre Teilhard de Chardin : «Non ho scoperto faticosamente il Tutto. Ma è lui che, attraverso una sorta di “coscienza cosmica” si è presentato, imposto a me».¹⁷
Ma la totalità comprensiva di questo “Grande Fuori” (o Totalità onnicomprensiva) non sarebbe tale se non comprendesse e, perciò stesso, non fosse anche un “Grande Dentro”, quel “Dentro” in cui si radica e alimenta lo stesso intuire, ossia proprio il pati dell’intelligere; infatti, come sottolinea Sergio Givone «se il soggetto non tirasse fuori quell’idea dalle profondità della sua anima; se il soggetto non riconoscesse nell’idea di infinito qualcosa che gli appartiene e che è tutt’uno con la sostanza più intima del suo essere, nessun infinito apparirebbe, nessuna infinità della natura gli si svelerebbe, nessuna infinità reale e nessun infinito ideale potrebbero mai diventare oggetto del pensiero»,¹⁸ “oggetto di pensiero” da intendersi, naturalmente, in quel senso simbolico-anagogico che sopra già si è detto.
Qui, allora, l’intuizione dell’infinito rivela ed esprime un’innegabile antecedenza e vincolatività che riescono a sfidare e superare qualsivoglia dubitare, perché, come scrive Heinz Heimsoeth, «il dubitante sa già, nel suo stesso domandare del non-limitato, dell’esistenza della verità tutta intera; l’idea dell’infinito non nasce in noi dall’incremento del finito, ma nel pensiero di ciò che è limitato è già sempre posta, come prius reale, l’infinità da cui questo stesso limitato è ritagliato».¹⁹
Dunque, la priorità dell’infinito sul finito si può intendere
anche nel senso che il finito non riesce a consistere in se stesso, e anche il
limite entro cui fissarlo (fissare il finito) è sempre arbitrario. Volendo
partire dalla definizione di “finito”, la determinazione di qualsiasi cosa si
presenta come un compito disperato, proprio perché nel riconoscimento
(arbitrario) dei suoi limiti ci si trova nell’inevitabilità di superarli.
Per questo, allora, la priorità reale e concreta non è del finito, ma di quella
totalità che lo circoscrive e lo determina, totalità infinita/indeterminata (àpeiron) della quale esso (finito) è la
limitazione o il ritaglio appunto, e con la quale (totalità infinita) esso
finito sta sempre in relazione perché, come ricorda Alfred North Whitehead, «nessuna prospettiva finita permette a una
qualsiasi entità di disfarsi della sua relazione essenziale con la totalità».²⁰
Pertanto, se il finito è dato, è dato sempre nella sua relazione con
l’infinito, anche inteso solo come infinito potenziale: ogni finito è sempre
circoscritto da un orizzonte infinito: rapporto tra parte e tutto.
Insomma, «quando io parlo di una cosa senza ancora riflettere se essa sia
infinita o finita, è l’infinito quello a cui tendo. Così in un certo senso
“l’idea dell’infinito è in me prima di quella del finito».²¹
Così come l’idea di relativo è già contenuta in quella di Assoluto.
Ecco perché, allora, devo pensare che “tracce di Assoluto”, prima ancora di essere un ‘prodotto’ dell’attività di un pensiero, risulta essere, innanzitutto, il vincolo di un passivo pensare, come sopradetto: “scire est agere, intelligere est pati”.
Perciò, è proprio questo pati dell’intelligere che mi rivela un’antecedenza e un vincolo, allo stesso tempo, nel mio pensare l’infinito, e mi svela, infine, che – facendo riecheggiare il verso del grande Giacomo Leopardi – sia o no “dolce”, è comunque certo “il naufragar in questo mare”.²²
4 . Luce dell’Essere e vivere nell’Assoluto
Per quanto percepiamo, sentiamo, affermiamo, neghiamo, dubitiamo, interroghiamo, ricordiamo, dimentichiamo … siamo, comunque e necessariamente, costretti a pensare: esistiamo! Come se ci trovassimo, senza averlo potuto decidere, in quella «luce dell’essere» (che tale è persino in un “buco nero”) che ci costituisce e che, lo vogliamo o no, ci contiene sempre e comunque.
Con parole altamente speculative, così ce lo insegna Antonio Rosmini: «L’essere dunque per sé manifesto conviene che manifesti e così sia manifestante e che manifesti se stesso e così sia ad un tempo manifestato; e di più che queste due qualità di manifestante e di manifestato costituiscano l’identico atto della sua natura: a queste condizioni l’essere è per sé manifesto. […] L’essere dunque dee avere per la prima dote questo di manifestarsi per se stesso, di essere luce».²³
È «luce dell’essere» quella che continua ad «essere» anche per chi decide di chiudere gli occhi, se non altro perché tale «luce d’essere» continua a costituire e a contenere sia gli occhi che si chiudono sia la decisione di chiuderli, e costituisce e contiene, inoltre, l’illusione stessa (l’essere dell’illusione) di poterla spegnere.
Si nasce nella presenza e nella visione dell’«essere», nonostante non ci si badi o ci si badi molto tardi, a causa di una certa pigrizia mentale o di un’abitudinaria negligenza; ma alla filosofia spetta il compito di recuperare, tramite la riflessione, questa consapevolezza dell’ «essere»; il suo impegno consiste, dunque, nell’aprire e mantenere aperti gli occhi alla «luce dell’essere». È in questa luce che cerchiamo quella «conclusione delle conclusioni in cui la realtà diventerà assolutamente trasparente a se stessa»²⁴, come scrive Ugo Spirito.
Ancora Assoluto, dunque!
Se in questo momento qui si rivelasse, apparisse il compiuto senso del mio esistere, ogni altra intenzione, come quella di continuare a scrivere ad esempio, ogni altro desiderio, ogni altra speranza e progetto futuro si estinguerebbero, trovando il loro compiuto perché e senso di fondo. Dunque, vivo in una sostanziale relatività di aspetti e dimensioni, vivo un determinato numero di limiti, e perciò non riesco a cogliere la compiutezza del quadro che essi compongono. Guardo il quadro della mia vita, ma, nello stesso tempo, resto all’interno di esso e continuo ad aggiungergli ulteriori pennellate: movimento asintotico che ancora mi rivela un senso d’infinitezza.
La “conclusione delle conclusioni” potrebbe allora essere quello dell’ultima pennellata che però, per essere tale, dovrebbe ricomprendere anche tutte le precedenti, a cominciare dalla prima: la chiusura di un cerchio, insomma, di una “realtà assolutamente trasparente a se stessa”: non posso accontentarmi di niente di meno che della “conclusione delle conclusioni”, ossia dell’Assoluto, proprio perché, come sentenzia Andrea Emo, «L’uomo non ha mai raggiunto l’assoluto, ma non è mai vissuto fuori dall’assoluto né senza assoluto».²⁵
Senza una qualche traccia di Assoluto, dunque, non vi sarebbe che l’abisso del pensiero e la tenebra del silenzio, anche se bisogna pur sempre affermare che l’Assoluto ha a che fare con il vivere, ancor più e ancor prima, che con pensieri e parole.
Ma, ora, mi sto muovendo tra quest’ultimi, pensieri e parole appunto; accingendomi a pensare e a scrivere devo fare affidamento a qualche solido fondamento, ad una qualche traccia di Assoluto, su cui appoggiare senso e significato di ciò che penso e scrivo. Diversamente, qualsiasi parola, a cominciare da quelle che ho già scritto, sto scrivendo e mi accingo a scrivere, varrebbe tanto quanto un qualsiasi caotico, effimero e casuale rumore producentesi nel cosmo infinito o, forse, sarebbe meglio dire, in un infinito caos. Devo confidare di vivere nell’Assoluto – accettando preventivamente il mistero che apre per me questa parola, mistero solo in parte attutito dalle sue tracce –, ancor prima di tentare di pensarlo o, quantomeno, coglierne le tracce, per sostenermi e continuare a pensare e a scrivere.
E come l’infinito, nella sua eccedenza, precede e ad un tempo significa/dà significato al finito, così – e ancor più – l’Assoluto, nella sua originaria ed assoluta ulteriorità, attesta il relativo, significandolo appunto nella sua relatività; di modo che, non riuscirei a rendermi conto della mia finitezza e relatività se sia l’infinitezza sia, ancor più, l’Assoluto, seppure in forma limitata ed astratta, non mi si rivelassero nella loro misteriosa evidenza. Infatti, dell’Assoluto bisogna pensare ciò che Ernst Bloch scrive del summum bonum, ossia che «è presente nella sua forma più rigorosa solo come domanda, come cifra che albeggia verso la soluzione, non già come soluzione»;²⁶ questo per dire come l’Assoluto si presenti quale visione ideale/simbolo vitale (cifra) che, risplendendo all’orizzonte, si protende al meriggio della sua realizzazione: questo il pensiero-speranza o l’utopia concreta che ci viene proposta dalla magistrale e profonda lezione di Ernst Bloch; un pensiero-utopia per il quale «il sapere del futuro viene non solo capito ma anche voluto e applicato contro un dubitare vile e miope».²⁷
Come sostiene Francesco Totaro, «Nell’impiego della nozione di assoluto, per un verso l’idea di assoluto interroga l’esperienza ‘istruendo’ la domanda intorno alla sua equazione o meno con la totalità del reale, per altro verso questa domanda si innesta nella medesima auto-manifestazione dell’esperienza e, più precisamente, nella inevitabilità che sia essa stessa a interrogarsi sul proprio statuto di parzialità o di totalità. […] Per un verso l’idea dell’assoluto introduce una tensione nella rappresentazione autosufficiente (o presunta tale) dell’esperienza, per altro verso quest’ultima è già gravida della tensione all’altro da sé».²⁸
Pensare all’Assoluto, che perciò è anche sempre necessariamente un pensare nell’Assoluto, vuol dire allora dover, da subito, riconoscere anche l’astrattezza (umbratilità di bruniana memoria²⁹) di ogni parola con cui cerchiamo di intendere e descrivere la nostra esistenza; perciò verità, libertà, amore, male, bene, giustizia, ingiustizia, speranza, disperazione, conoscenza, ignoranza, etc. indicano solo una parte e, dunque, un astratto, di quel Concreto che tale è “Ciò che tutto può comprendere ed essere”: ecco ciò che si vuole o, meglio, che si cerca di esprimere con la parola Assoluto. Come suggerisce Bloch: «Una volta, da una qualunque parte, dovrebbe esserci un “Fin qui e non oltre”, non una dichiarazione di rinuncia, come di solito, ma di adempimento. In cui è pensabile un valore principale, che sta in sé e per sé non oscilla né verso il basso né verso l’alto e a partire dal quale, anzi a procedere verso il quale sono misurabili i beni».³⁰
L’intuizione delle tracce di Assoluto, come intuizione finita di un’infinita profondità e di un’infinita vastità, manifesta la sua finitezza (astrattezza) nei confronti dell’Assoluto proprio anche nel fatto di pensarsi ed esprimersi come duplicità: la duplicità di queste due aspetti d’infinito, aspetti di intensità e di estensività (intensive ed extensive) o profondità e vastità, appunto.
Ma l’Assoluto non può ragionevolmente venir pensato come ‘duplice’, semmai è l’unicità la peculiarità che, in esclusiva, può sensatamente appartenergli; perchè è proprio una unicità assoluta a poterlo o, meglio, a doverlo contraddistinguere come Absolutum, ossia come “Sciolto”, “Libero” da qualsivoglia limite, come sopra già sottolineato; libero, perciò, anche dalle tracce che lo rivelano: libero tanto dall’intuizione che lo intuisce quanto dal pensiero che lo pensa.
Baruch Spinoza ce lo indica attraverso il concetto di “causa sui”, concetto che senza dubbio riesce ad esprimere con particolare efficacia speculativa l’inaccessibile profondità dell’incondizionata libertà dell’Assoluto: «Per causa di sé intendo ciò la cui essenza implica l’esistenza, ossia ciò la cui natura non si può concepire se non esistente»;³¹ l’Assoluto possiede perciò un’ “assoluta libertà” perché è essenzialmente “causa di se stesso”.
Allora, se nell’intuizione dell’infinità delle tracce di Assoluto si è rilevata un’ineludibile eccedenza di pensiero, qui, nell’idea di “qualcosa” che sia “causa di se stessa”, l’eccedenza di pensiero comporta un ulteriore grado di inconcepibilità – ma, non inibisca la nostra “brama di assoluto” il prendere coscienza dell’ “inconcepibilità di un concetto”, perché filosofare è proprio dover sostare e continuare a pensare fra queste eccedenze semantiche e paradossi logici –, inconcepibilità che verrebbe, inoltre, accentuata e sentita in una maniera estremamente inquietante se “Colui che/Ciò che” viene pensato come “causa sui” fosse inteso come privo di consapevolezza; che strana e, persino, orrenda – quantomeno per il nostro pensiero, umano troppo umano – sarebbe, infatti, l’idea di un ‘Assoluto’ che, pur creandosi e sostenendosi da se stesso, fosse però privo di autocoscienza!
Quest’ultima sconcertante ipotesi e angosciante prospettiva mi porta inevitabilmente a concludere queste riflessioni intorno all’Assoluto ritornando all’autore da cui esse hanno preso le mosse, ossia a Kant che in un celeberrimo passo della Critica della ragion pura scrive: «Non è possibile né evitare né accettare che un essere, da noi assunto come il sommo di tutti gli esseri possibili, in un certo modo dica a se stesso: “Io sono dall’eternità e per l’eternità, all’infuori di me non esiste se non ciò che trae l’essere dalla mia volontà; ma donde provengo io allora?” Così ogni cosa sprofonda sotto i nostri piedi …».³²
Note
1 . A. Camus, Il mito di Sisifo, tr. it. A. Borelli, Bompiani, Milano 1980, p. 20.
2 . I. Kant, Che cosa significa orientarsi nel pensiero, a cura di F. Volpi, Adelphi, Milano
1996, nota 1, p. 52.
3 . Citata da F. W. J. Schelling, Filosofia della Rivelazione, a cura di A. Bausola, Rusconi,
Milano 1997, p. 59.
4 . M. Cacciari, Labirinto filosofico, Adelphi, Milano 2014, p. 71
5 . Ivi, p. 72
6 . Anselmo d’Aosta, Proslogion, a cura di L. Pozzi, Fabbri Editore, Milano 2006, cap. IV,3.
7 . AA. VV., Pensare l’Assoluto, a cura di L. Ghisleri, Edizioni Studium, Roma 2014,
pp. 45, 47.
8 . R. Ronchi, Come fare – Per una resistenza filosofica, Feltrinelli, Milano 2012, p. 63.
9 . E. Bloch, Spirito dell’utopia, tr. it. V.Bertolino/F. Coppellotti, Sansoni, Milano 2004,
pp. 251-52.
10 . Versi tratti da F. Hölderlin, Pane e vino, in Poesie scelte, a cura di S. Mati, Feltrinelli,
Milano 2010.
11 . Citato in M. Cacciari, Dell’Inizio, Adelphi, Milano 1990, p. 134.
12 . Cfr. H. von Hofmannsthal, Lettera di Lord Chandos, tr. it. R. Ascarelli, Edizioni Studio
Tesi, Pordenone 1992.
13 . E. Lévinas, La filosofia e l’idea dell’infinito, in E. Lévinas/A. Peperzak, Etica come
Filosofia prima, a cura di F. Ciaramelli, Guerini e Associati, Milano 1989, p. 42.
14 . Merita riportare l’ultima strofa da cui ho tratto questa citazione poetica: … Io ti dirò
verso quali reami / d’amor ci chiami il fiume, le cui fonti / eterne a l’ombra de gli
antichi rami / parlano nel mistero sacro dei monti; / e ti dirò per qual segreto /
le colline su i limpidi orizzonti / s’incurvino come labbra che un divieto / chiuda,
e perché la volontà di dire / le faccia belle / oltre ogni uman desire / e nel silenzio
lor sempre novelle / consolatrici, sì che pare / che ogni sera l’anima le possa amare
/ d’amor più forte.
Laudata sii per la tua pura morte, / o Sera, e per l’attesa che in te fa palpitare / le
prime stelle.
Da G. d’Annunzio, La sera fiesolana, in Id. Alcyone, a cura di F. Roncoroni, Mondadori,
Milano 1995.
15 . M. Fantinelli/A. Stella, Intentio Dei – Lo slancio verso l’infinito, Armando Editore,
Roma 2014, pp. 40, 113, 146.
16 . R. Ronchi, Il canone minore – Verso una filosofia della natura, Feltrinelli, Milano 2017,
p. 132.
17 . P. Teilhard de Chardin, Il mio Universo, in Id. La scienza di fronte a Cristo, a cura di
S. Procacci, Il Segno dei Gabrielli, Verona 2002, p. 71.
18 . S. Givone, Sull’infinito, il Mulino, Bologna 2018, p. 62.
19 . H. Heimsoeth, I grandi temi della metafisica occidentale, tr. it. F. Moiso, Mursia,
Milano 1972, p. 84.
20 . A. N. Whitehead, Dio e il mondo, l’immortalità, a cura di N. Bosco, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli 1993, p. 41. Sulla misteriosa evidenza di questa ‘interrelazione
universale’ voglio lasciare la parola alla geniale poesia speculativa di Rainer Maria
Rilke: Lode allo Spirito che sa connetterci, / perché la nostra vita è fatta di figure. /
E il nostro giorno autentico non si misura / sul passo minimo delle lancette. //
Pur ignorando il nostro posto vero, / nell’azione un reale Rapporto ci orienta. /
Le antenne sentono le altre antenne, / e messaggi attraversano le vuote lontananze.
(due quartine tratte da Sonetti a Orfeo, XII).
21 . H. Heimsoeth, cit., p. 84.
22 . Da L’infinito di Giacomo Leopardi.
23 . A. Rosmini, Teosofia, Bompiani, Milano 2011, paragrafi 1509, 1510.
24 . U. Spirito, La vita come ricerca, Luni Editrice, Milano 2000, p. 101.
25 . A. Emo, Il monoteismo democratico, Mondadori, Milano 2003, p. 3.
26 . E. Bloch, Il principio speranza, tr. it. E. De Angelis/T. Cavallo, Garzanti, Milano
2005, p. 1544.
27 . Id., p. 1477.
28 . F. Totaro, Assoluto e relativo, Vita e Pensiero, Milano 2013, pp. 49,50.
29 . Scrive Giordano Bruno: «L’ombra non è tenebra, ma orma di tenebre nella luce, o
orma di luce nelle tenebre, o partecipe di luce e di tenebre, o composto di luce e di
tenebre, o miscuglio di luce e di tenebre», per questo «va considerata orma di luce,
partecipe di luce, luce non piena. […] non alludo infatti all’ombra che allontana dalla
luce, ma a quella che guida alla luce, che pur non essendo verità, tuttavia proviene
dalla verità e porta alla verità, pertanto non devi supporvi errore, ma latenza del
vero». G. Bruno, De umbris idearum, a cura di C. D’Antonio, Di Renzo Editore,
Roma 2008, pp. 33-34 e 41.
30 . E. Bloch, cit., p. 1516.
31 . B. Spinoza, Etica, tr. it. S. Giametta, Bollati Boringhieri, Torino 1992, parte I, def. I;
parlando della libertà dell’Assoluto, devo citare almeno il primo enunciato della VII
definizione: «Si dice libera quella cosa che esiste per sola necessità della sua natura, e
si determina ad agire da sé sola …».
32 . I. Kant, Critica della ragion pura, a cura di P. Chiodi, UTET, Torino 1967, p. 490.
Aggiunto il 11/11/2018 07:51 da Alfio Fantinel
Argomento: Filosofia teoretica
Autore: Alfio Fantinel

E’ davvero conclusa la parabola del modo di fare filosofia – che è stato quel modo stesso della filosofia della tradizione risalente a Platone e Aristotele, significativamente definita dei

Riflessioni a margine del testo di Habermas: “Morale, Diritto, Politica” LA FORMA ASTRATTA E UNIVERSALE DELLA LEGGE “Vi sono 144 usanze in F

Ho notato che spesso discutendo dei più svariati temi, ma soprattutto di attualità politica, ricorre frequentemente da più parti l'appello alla "legalità". Indubbiamente è importante che lo s